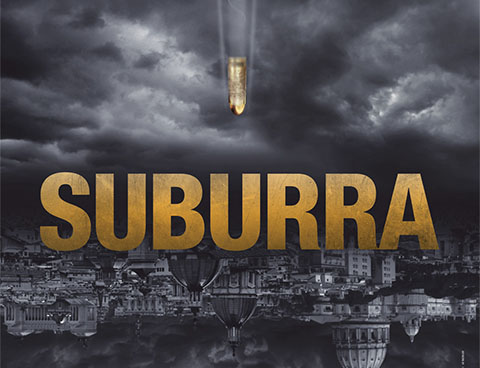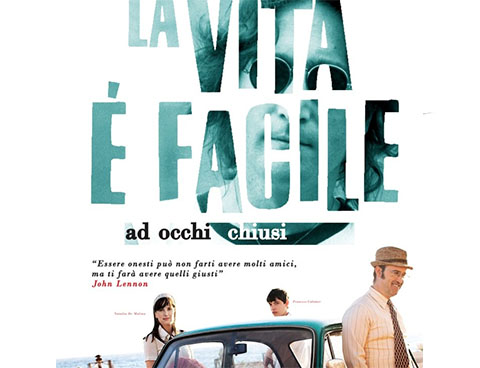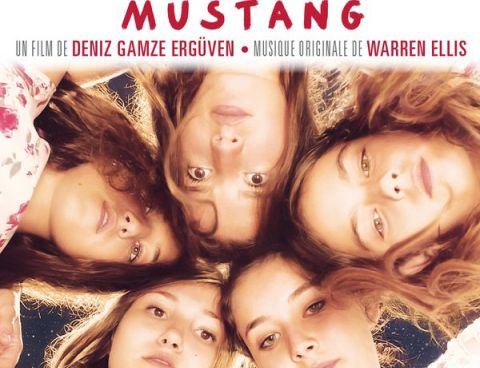AltrodiBlogger Erranti,20 aprile 2013
John: la recensione
Comincia nel foyer del Teatro dell’Orologio, il viaggio nel dolore e nella perdita di un affetto, di John, dal testo di Wajdi Mouawad e per la regia di Giuseppe Roselli. Ad accoglierci in una scenografia di pareti di tela, in una foresta di alberi grigi e secchi, un’apparizione quasi fiabesca, una fanciulla col cappotto rosso che fa il verso a Cappuccetto, Jeanne, che stringe un diario in mano invitandoci a leggerne qualche stralcio. È il diario del fratello John che ci restituisce la sua sofferenza muta e incomunicabile, il male di vivere che si deposita ogni giorno su una pagina bianca tingendola di nero, quel nero che John ha “addosso e che cresce”.
“Raccontare non serve a consolarsi, ma riempie”, dice Jeanne che, insieme allo spettatore, prova a spiegarsi John e il motivo che lo ha spinto al suicidio, senza trovare soluzioni. È un itinerario nel dolore quello che Jeanne, virgiliana guida negli inferi, ci invita a compiere attraversando spazi contigui (le due sale del teatro) e tempi sovrapposti (il passato rievocato dell’infanzia e il fantasma di John, la sua presenza oltre la morte che ha segnato per sempre il futuro della sua famiglia). Veniamo introdotti nella stanza di John mentre ascolta un brano punk ad alto volume: vestito di nero da capo a piedi, è già pervaso di morte e di distruzione. Il video del suo testamento prima di morire è una confessione spezzata, spesso interrotta dal formicolio dello schermo, frantumata come le parole che John non sa dire, come il malessere che non può condividere e di cui nessuno è colpevole.
Un tavolo sgangherato, ante di mobili rotti ci restituiscono i pezzi infranti di una famiglia distrutta, il divano ribaltato sul soffitto la perdita di senso delle cose. Le sedie accatastate e inservibili, su cui non ci si può sedere, parlano di un posto, di una casa dove non si può più stare, dove non ci si ferma più, e della frustrazione di John, un adolescente che non trova la propria dimensione nel mondo, un giovane che non riesce a rintracciare lo spazio del proprio sé.
Sul tavolo inclinato dell’inevitabile, dove Jeanne fa scivolare teglie, formine, uova, farina e il necessario per i suoi biscotti, niente può mettersi in salvo, le cose sono destinate a crollare e a infrangersi, come John che non poteva essere sottratto alla morte. La sua vita è come i biscotti non riusciti di Jeanne che si tormenta, si sente colpevole per non aver ascoltato il fratello e non essersi presa cura di lui. Anche lei ha disimparato a vivere: il suo leccarsi compulsivamente le dita è il tentativo di recupero di un’età dell’oro, dell’infanzia spensierata, di quando tutto era bello, è il tentativo sempre inappagato di ritornare alla normalità. Ma come imparare a inghiottire la saliva, “con un coltello piantato in gola?”.
“Il dolore passa” sussurra Jeanne, mentre slega i nodi irrisolti della vita e della morte di John, quei groppi in gola che sono dei macigni sul cuore. Il dolore passa, cioè si trasferisce, si trasmette a chi resta, sembra suggerirci la messa in scena di Giuseppe Roselli, che ci parla della sofferenza di vivere con poesia e sentimento. Anche attraverso la scenografia percorribile, carica di segni e di significat,i e il coinvolgimento diretto del pubblico che si sente quasi uno di famiglia, chiamato a omaggiare la memoria di John e a condividere un lutto. Ma soprattutto grazie all’eccellente prova di Barbara Mazzi, una dolce e straziante Jeanne, e di Marco Lorenzi, un vitale e cupo John, il testo di Wajdi Mouawad si fa vivo e penetrante e “passa” a noi come una scheggia nella carne.
Scritto da Vera Santillo.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.