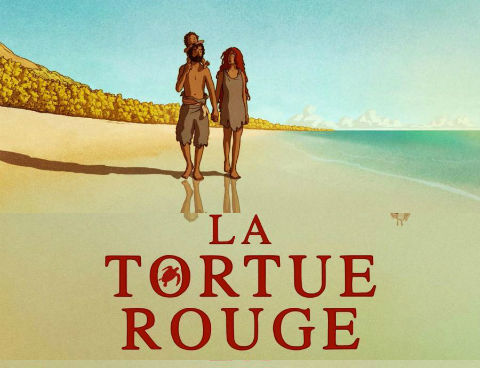La legge del mercato: la recensione
Vincent Lindon, miglior attore a Cannes 2015, ci mette la faccia (espressiva), dietro la regia sottile di Brizé

L’hanno detto in tanti: La legge del mercato di Stéphane Brizé ricorda lo stile naturalistico dei fratelli Dardenne. Certo, però, deve esserci qualcosa di soprannaturale nel fatto che un film così noioso tenga incollati allo schermo, dettaglio ordinario dopo l’altro, in stanzucole d’istituti bancari e supermercati dove ci si abbuffa di dialoghi, sorbendosi persino lo sforzo di cogliere certi passaggi narrativi mancanti per volontarie omissioni dell’autore. Non arriva nemmeno il premio di consolazione: nessuna svolta thriller, banditi i colpi di teatro, si procede per accumulo di umori, tutti lì, tra viso e posture di Vincent Lindon, premiato come miglior attore a Cannes 2015.
50 anni e passa, Thierry ha sulle spalle la famiglia composta da moglie e figlio disabile e sullo stomaco il magone d’un licenziamento inatteso che lo costringe a rimettersi in gioco, tra surreali colloqui via Skype, estenuanti trattative per vendere un immobile, ambigui consigli di consiglieri bancari. Nessuno, però, gli ruba né la dignità, né il sorriso per i piaceri semplici, come un corso di ballo con la moglie o uno scambio di battute col figlio. In tema di furti, infine, arriva il sospirato posticino: vigilante addetto al controllo in un supermercato. I conti a fine mese si aggiustano, ma restano da fare quelli con la coscienza al presentarsi di un dilemma morale.
Costretto a masticare amaro da un freddo sistema lavorativo che mastica ed espelle come una macchina tritacarne, il simple man impersonato da Vincent Lindon sotto il baffone fiero è un campione di verità umana, il cui cuore vien fatto risuonare nella misura di una ruga, di un’esitazione, di una microespressione, perché il film sia un incontro più che un racconto. Il cast di attori dilettanti – molti dei quali svolgono nella vita le medesime mansioni del film – rafforza la credibilità d’un film che si fa a pezzi per raccontare un sistema che fa a pezzi: scene e situazioni circoscritte si aggregano con linearità ma con ellissi nella narrazione, costituendosi come frammenti d’esistenza, anziché come costrutti di sociologia spicciola (a dispetto dell’ingannevole titolo italiano).
Dietro tanta naturalezza, persino irritante per quanto diventa scabra l’esposizione, si cela però un’effettistica sottile: si sarebbe tentati di dire che il film è solo Lindon, ma è la cornice costruita da Brizé a farne emergere il quadro emotivo. Due esempi su tutti: le inquadrature che puntualmente schiacciano sul bordo destro o sinistro del campo Thierry, rilevandone la distanza, se non il distacco, da un mondo disumano; certi sfondi fuori fuoco, come se il protagonista volesse respingere la visione di quel mondo, de-sintonizzarsi. La sintonia emotiva con lo spettatore, però, è costante.

| Antonio M. | ||
| 7 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast: