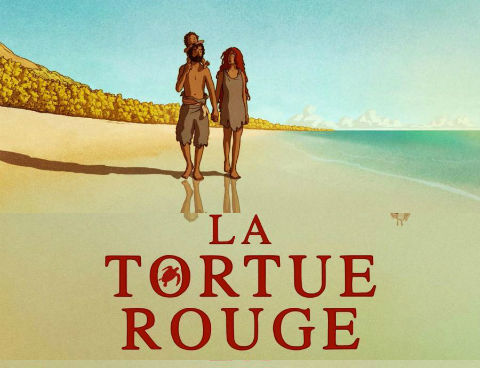Amy – The Girl Behind the Name: la recensione

Presentato fuori concorso a Cannes e in anteprima italiana al Biografilm Festival, il toccante documentario AMY – The girl behind the name arriva in sala il 15, 16 e 17 settembre. Il regista Asif Kapadia, autore dell’acclamato Senna (premiato al Sundance 2011 e ai BAFTA 2012), torna a dar prova del proprio talento con un’opera intensa che tratteggia l’ascesa e la successiva spirale autodistruttiva della tormentata cantante Amy Winehouse, spentasi tragicamente nel 2011 ad appena 27 anni.
Kapadia bilancia l’approccio documentaristico, necessariamente ruvido e schietto nel riprendere scene di profonda sofferenza e solitudine, con una narrazione emotivamente intensa che pure non scade mai nel sentimentalismo agiografico. Regia e montaggio riproducono la parabola della cantante: è Amy stessa a dirigere virtualmente la prima parte del film, con la portata quasi diaristica dell’ampio corredo di filmati casalinghi e d’archivio di compleanni, viaggi in macchina e registrazioni in studio (particolarmente toccante quella con un premurosissimo Tony Bennett), dai quali traboccano una personalità e una voce impossibili da circoscrivere con uno sguardo registico. Tuttavia, man mano che la protagonista scivola nel vortice di alcol, droghe e frequentazioni deleterie (in primis il marito eroinomane Blake Fielder-Civil), è Kapadia a prendere in mano le fila della narrazione, di fatto ricomponendo un percorso di vita che la Winehouse non poteva più controllare autonomamente.
La chiave interpretativa è fornita, come prevedibile, dai brani musicali che la cantante utilizzava a scopo catartico, tanto in fase di scrittura (i testi su dipendenze e amori devastanti non lasciano dubbi), quanto in fase di perfomance, con la sua voce così potente da essere spesso definita “nera”. Kapadia mette in luce il profondo dolore che animava testi ed esecuzione, troppo spesso nascosto dietro il potentissimo sorriso della vocalist e dietro i riflettori di un successo improvviso e travolgente, e affresca il mondo di Amy con pennellate violente e spigolose, ma quantomai realistiche e necessarie.
Ne emerge una famiglia indubbiamente colpevole, con una madre (separata) che dichiara di non aver capito i problemi di bulimia che la figlia manifestava già in tenera età (“Ho trovato una dieta fantastica: mangio quello che voglio e vomito tutto”) e un padre assente fino al momento di monetizzare il successo e la fragilità di una figlia che non aveva mai smesso di venerarlo. Un padre che per primo ha risposto “No, no, no” quando gli amici storici “tried to make [her] go to rehab“, segnando forse il punto di non ritorno per Amy. Ne emerge poi una giungla di sciacalli, dimensione certo intuibile, ma che colpisce ugualmente allo stomaco a ogni lotta dei paparazzi per accaparrarsi un’immagine della Winehouse in piena crisi. Ma ne emerge anche un pubblico che si scopre complice involontario ed esce dalla sala rendendosi conto di aver guardato Amy Winehouse spegnersi proprio sotto i riflettori.
| Alice C. | ||
| 9 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast: