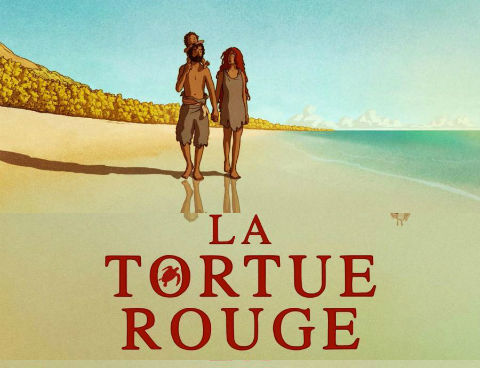Ritorno alla vita: la recensione
Un 3D sperimentale per un dramma dalla freddezza della provetta alchemica

Dell’ultimo Wim Wenders sono assodate due cose: che la strada più promettente della sua maturità sia il documentario, come attesta il recente Il sale della terra; che il maestro tedesco stia sviluppando una particolare predilezione per l’uso del 3D, ben valorizzato in Pina e ulteriormente esplorato nel film collettivo Cattedrali della cultura. Ritorno alla vita, il ritorno alla fiction dell’autore, può allora essere considerato benignamente come una transizione sperimentale, per l’utilizzo del 3D nel genere drammatico; o, più obiettivamente se non più impietosamente, lo stringente indizio di uno sguardo ormai più illuminato nell’organizzazione del materiale documentario che nel racconto d’invenzione.
A proposito di crisi creative: James Franco è uno scrittore che vive un periodo di stagnazione. L’inversione di rotta avviene in occasione di un tragico evento, l’investimento involontario di un bambino, accompagnato dal fratellino. Solo quest’ultimo sopravvive, rimanendo traumatizzato a vivere insieme alla madre single (Charlotte Gainsbourg). Durante l’elaborazione piuttosto sotterranea dello shock, lo scrittore, nell’arco di dodici anni, vede la propria fortuna crescere, mentre dal punto di vista sentimentale passa dal giovanile bollore (Rachel McAdams) a una relazione più stabile con l’editrice Ann (Marie Joose-Croze), madre della piccola Mina. Qualche mina emotiva, però, non sembra ancora esplosa.
Un gelido inverno prima della primavera, si potrebbe sinteticamente definire Ritorno alla vita, sceneggiato senza calore dal norvegese Bjorn Olaf Johannessen e ambientato per lo più nel candido rigore del Canada. Il problema, per l’appunto, è di freddezza: a uno script incapace di penetrare le lastre di ghiaccio di sentimenti ermetici, si combina l’ibernante interpretazione di James Franco, certo, istruito – malamente – in questo senso di piattume depressivo. Il dramma slow, confermato dalla sofferenza zen della Gainsbourg, è un genere praticabile con profitto, ma richiede una cura maniacale per i dettagli, che Wenders sembra piuttosto aver profuso nella fotografia che nell’alchimia dei personaggi.
L’uso del 3D è più straniante che efficace, specie accompagnato ai movimenti della macchina (molti piani sequenza) e a un abuso di dissolvenze: tutti saggi di maestria poco saggiamente dispensata e non pienamente amalgamata in un prodotto coeso e comunicativo. Ecco, a volte sembra più un prodotto alchemico: una qualche formula che preferisce tenersi una quota d’indecifrabilità. Allo spettatore spetta stabilire il confine tra il fascino del non detto e la frigidità di un inverno espressivo.

| Antonio M. | ||
| 5 |