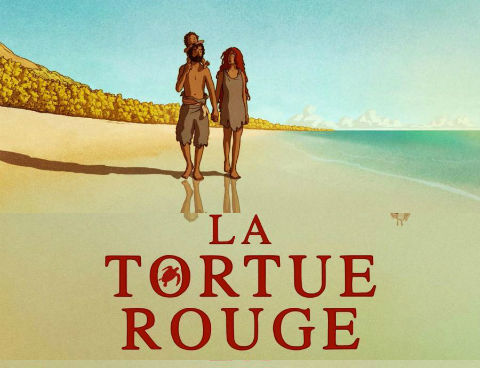La canzone perduta: la recensione
Il film di Erol Mintas evoca con sensibile realismo il travaglio di una madre e del popolo curdo

La storia de La canzone perduta comincia qui, con una storia interrotta: nel 1992, in un remoto villaggio curdo, un insegnante racconta animatamente alla classe di preadolescenti la favola di un corvo che sogna di diventare un pavone. Dalla mimica attoriale, che compiace i ragazzi all’ascolto, passa al conato di liberarsi dalla morsa di un gruppo di uomini armati, che fanno irruzione nella classe e lo prelevano forzosamente. Non ne conosceremo mai le sorti, immaginabili. 20 anni dopo, il curdo Ali, ad Istanbul, fa faticosamente il maestro, con la polizia che gli tiene gli occhi incollati addosso; faticosamente il figlio, con l’anziana madre Nigar che lo secca chiedendogli di tornare al villaggio e di reperire una canzone di gioventù svanita nel nulla; faticosamente il partner, con la compagna che gli annuncia un’indesiderata gravidanza. E già essere curdi in Turchia è tutt’altro che facile.
Vincitore della 20esima edizione del Festival di Sarajevo, La canzone perduta (Song of My Mother) di Erol Mintas arriva con comprensibile ritardo in Italia, per quei caratteri che ne fanno film d’essai di spessore ma di non immediata ricevibilità per il grande pubblico: il sottotesto politico, con l’allusione alla democrazia turca, più formale che sostanziale (Ali riceve una fredda comunicazione che lo obbliga a motivare uno sciopero); il riferimento costante, ma opaco, al travaglio d’identità della comunità curda (la canzone del titolo, perduta come le storie, i luoghi, la tradizione); il passo rallentato, da neorealismo mediorientale, che senza clamori si muove tra periferie sordide e interni angusti.
Se c’è qualcosa che può avvicinare a platee allargate quello che, per essere un esordio, resta comunque un gioiellino, è l’umanissima interpretazione dell’attrice non professionista Zubeyde Ronahi, una madre convincente nello statuto di matriarca fragile e fiera, di martire passiva e aggressiva: un ritratto di encomiabile autenticità, che diventa splendido dittico insieme a quello che Feyyaz Duman dà del figlio, tra slanci d’amorevolezza e irritante incapacità di una piena empatia (anche con la compagna). La sottigliezza, pericolante, del filo che unisce questi affetti evoca l’afflizione di una comunità spezzata: Istanbul non accoglie, non affabula coi minareti, ma sembra un terreno minato (le autorità nell’ombra, i vicini che non aprono la porta, l’aria greve dei suburbi).
Allo spaesamento della madre contribuiscono anche i contatti con una modernità estranea: la cassetta di canto popolare che si rivela un fake di musica metal, la videochiamata con l’altro figlio attraverso lo gelido schermo, i colleghi di Ali che paiono divertirsi per qualche diavoleria sullo schermo di uno smartphone, mentre l’anziana è isolata su una panca, in secondo piano. Sono solo alcuni degli esempi di un racconto minimale, sensibile, che richiede una visione attenta per non dissipare, come polvere nel deserto, i frammenti di una storia che sembra trattenere l’emozione di tante storie.

| Antonio M. | ||
| 7 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast: