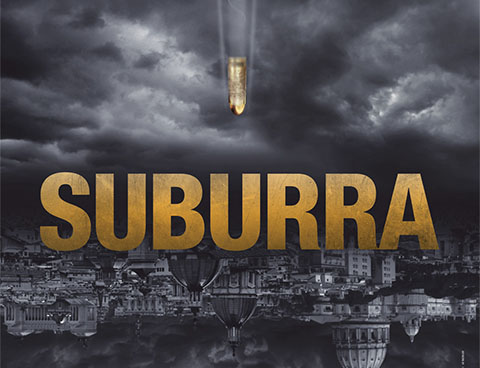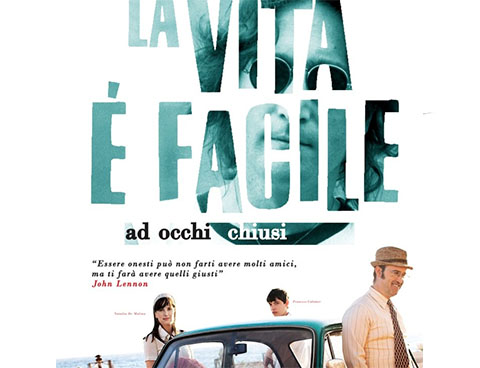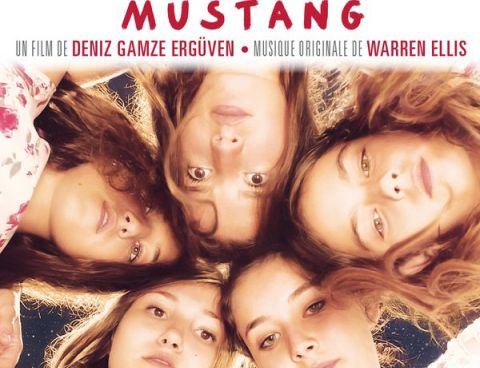AltrodiBlogger Erranti,20 febbraio 2013
La serata a Colono: la recensione
La serata a Colono: la litania come voce dell’ossessione e come tempo della Storia. Come far parlare l’ossessione? Attraverso una cantilena monotona. Come raffigurarsi la colpa se non come immanenza senza principio e senza fine? Se non avvicinandola all’essenza divina, all’eterno ciclo che non si genera e non si conclude, al sole che tramonta, ma non muore, all’astro che c’è sempre anche quando non lo si vede?
L’Edipo di Elsa Morante ha provato a spegnere l’astro sotto la cui luce ogni cosa diviene bianca, evidente, ma si è accorto che quella luce lui non l’ha estinta, l’ha solo imprigionata nelle orbite cave dei propri occhi. Il cieco Edipo, infatti, vede attraverso le bende, vede meglio di chi ci vede. Una cantilenante Antigone ciociara tenta di illuderlo, di convincerlo che quel muro bianco che li circonda è una cancellata di rose, che quelle grida disperate intorno a loro sono solo i fantasmi generati dalla “frebbe” che ha annebbiato la mente del padre. Sono le grida dei pazzi di un manicomio italiano, prima della legge Basaglia. Ma Edipo crede di essere a Colono, l’unico luogo dove la sua mente potrà trovare pace e dove in effetti la troverà sotto forma di un liquido benefico e di un pozzo gelido.
La serata a Colono messa in scena da Mario Martone, come il testo stesso della Morante, gira attorno a un unico perno, non può muoversi, non può prendere il largo perché è inchiodata a un centro e può solo ruotargli intorno. Questo centro è la colpa, la disgrazia che si incarna in Edipo che è “corpo di ogni antenato e di ogni progenitura”. La colpa, il male non finiranno con lui. La sua stirpe è condannata all’eterno ritorno del male, alla ciclica reiterazione dell’onta, alla necessità replicante della sciagura.
Il delirio di Edipo è un monologo con un’unica intonazione, un fiume inarrestabile. Solo gli interventi dei pazzi che girovagano fra il pubblico in platea e quelli della figlia Antigone interrompono il suo flusso continuo scandendone il ritmo. Il verso ricco, aulico, cangiante nelle parole ma sempre uguale nella sostanza della Morante, questo accartocciarsi, ricadere sempre su se stesso, questo dire la stessa cosa in mille modi diversi è già di per sé forma e contenuto del dramma ossessionante di Edipo. Ecco perché anche l’invocazione alle Erinni che è preghiera disperata, qui diviene enunciazione sterile di un elenco di sinonimi. La recitazione monocorde, la nenia assillante, la litania irritante di Carlo Cecchi che offre una prova disumana, cioè che va oltre le possibilità umane di un attore, l’immobilità del suo corpo che è immobilità claustrofobica della scena quasi vuota e poco animata dai corpi, contribuiscono a inchiodare ancora più saldamente l’ossessione al proprio centro. Il baluginio pungente di cui Edipo parla continuamente, questo Dio luminoso e ingannatore che ha preordinato la sua rovina compare in scena sotto forma di cerchio di luce che brucia, che obnubila, che acceca. A un certo punto il cerchio si trasforma in pendolo: nelle sue oscillazioni riconosciamo l’eterno andirivieni del Tempo che avanza uguale, ciclico, immancabile. Un tempo dal quale non si sfugge, un tempo che fa il conto alla rovescia di un destino calcolato e prefissato dagli dei e che contiene per intero tutta la Storia. Una storia dove “non c’è un inizio né una chiusa”.
Ma mentre il cerchio della Storia non si chiude, il dramma si compie restituendo Edipo alla carne della madre-sposa, al corpo in cui è nato, al grembo in cui tutto ha avuto origine.
Scritto da Vera Santillo.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.