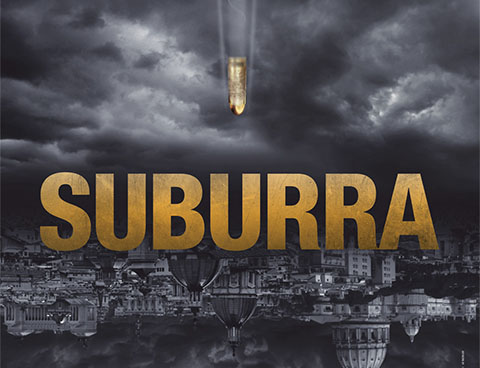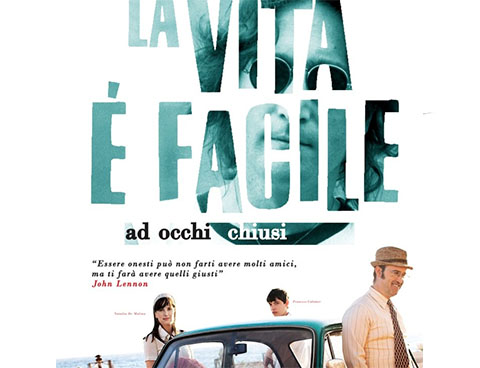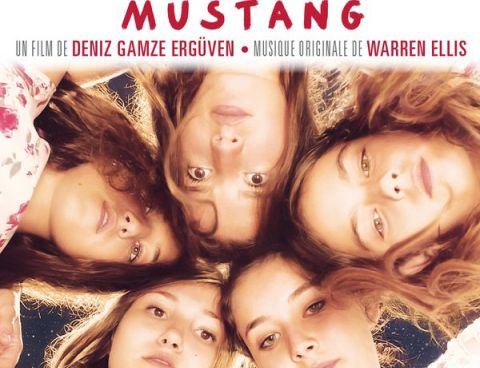AltrodiBlogger Erranti,13 giugno 2011
Fleet Foxes – Helplessness Blues
Anche per i Fleet Foxes, uno dei gruppi rivelazione del 2008, giunge il tempo del difficile secondo album. Difficile innanzitutto per la gestazione, che è stata lunga e travagliata avendo conosciuto dubbi e ripensamenti conditi da quello stress espositivo che ha fatto seguito ai clamorosi consensi raccolti un po’ ovunque. Meno problemi il quintetto di barbuti pseudo-boscaioli di Seattle li ha avuti col brillante risultato finale, pur se maturato in una fase delicata del loro percorso.
Se già con l’album d’esordio-disco di platino in UK- le Volpi ci avevano aperto occhi e orecchie di fronte ad un mondo fatto di melodie gentili e armonizzazioni à la Crosby, Stills & Nash, ora alla formula aggiungono anche aromi british folk mutuati dagli zii Fairport Convention e spezie medio-orientali, il tutto per un lavoro decisamente più denso e stratificato ma non per questo meno coeso.
Badi bene il lettore, non si tratta dell’ennesima celebrazione fuori tempo massimo dell’hippismo, chè se così fosse non ci si tirerebbe certo indietro dall’impallinare i barbudos di cui sopra. Quel che emerge è semmai un lavoro fatto col cuore, capace di conquistare ascolto dopo ascolto ben oltre il pur pregevole artigianato west coast.
Diversi i numi tutelari, l’avrete capito, e tutti o quasi appartenenti all’olimpo della musica folk e psych di fine anni sessanta/primi settanta. Oltre al già citato trio si sistemano nel pantheon dei nostri i Beach Boys, Simon&Grarfunkel e i Byrds ma anche Roy Harper, il Van Morrison di Astral Weeks e persino Morricone, che spesso viene infilato in questa o quella lista perché fa fico. Ecco allora una “Montezuma” in grado di riannodare i fili con l’esordio, cui fanno seguito l’arabeggiante “Bedouin Dress” e il tenue acquerello di “Sim Sala Bim”, sospeso a mezz’aria tra Brian Wilson e Paul Simon. “The Plains/Bitter Dancer” rimanda ai CS&N di Wooden Ships mentre la title-track segna un crescendo emotivo in grado di mutarsi in aria trasognata, meditabonda.
Il pregevole strumentale di “The Cascades” sfocia nella riscrittura della dylaniana Fourth time around che in “Lorelai” vede aggiunto nondimeno un tocco caraibico. Vero capolavoro del disco è però la suite (ebbene sì!) di “The Shrine/An argument” che in 8 minuti trova anche il modo di (s)piazzare (con) una coda free-jazz.
Osservate le diverse angolature ed innamoratevi dell’insieme perché Helplessness Blues si candida decisamente a diventare, volenti o nolenti, uno dei dischi dell’anno. Detto da chi si è appena comprato una camicia a quadri…
![]()
Scritto da Fabio Plodari.
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.