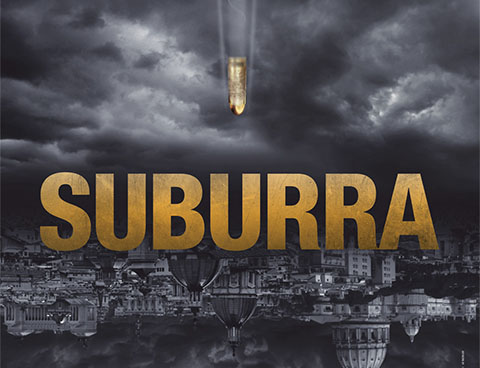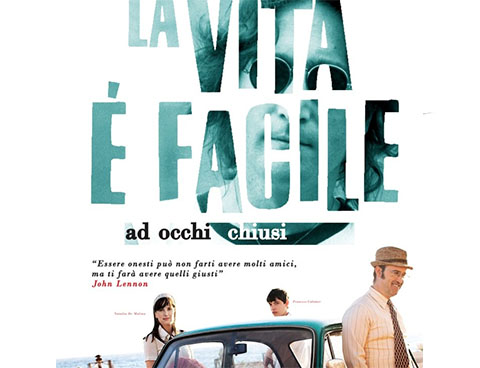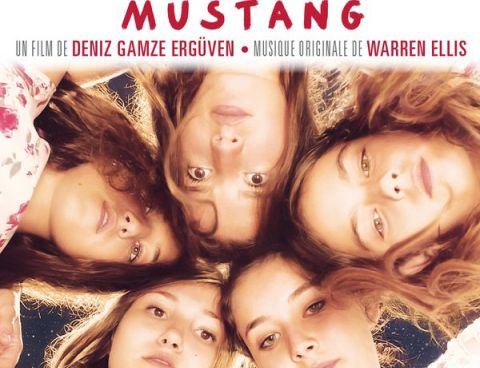Venezia 72. El Clan e altre recensioni

Il concorso di Venezia 72 ci sta regalando (pochi) alti e (molti) bassi. Appartiene sicuramente ai primi El Clan di Pablo Trapero, un gangster movie a sfondo politico incentrato su una storia vera, quella della famiglia Puccio, responsabile di un racket di sequestri e omicidi nell’Argentina dei primi anni Ottanta e collusa con la dittatura militare. Il film narra la vicenda dal punto di vista di Alejandro, uno dei figli, che gioca a rugby, si innamora di una ragazza e sogna una vita normale con lei, ma rimane invischiato nelle attività criminali pianificate dal padre Arquimedes. Il ritratto di questa impresa familiare dei sequestri, nascosta dietro alla facciata di una famiglia di onesti commercianti, colpisce per l’efficacia nel mostrare la doppiezza dei personaggi e l’assoluta naturalezza con la quale rapiscono, minacciano e uccidono persone mentre accompagnano i ragazzi a scuola o praticano sport; un comportamento che rispecchia, secondo il regista, quello dell’intero regime militare argentino, di cui Arquimedes era fedele alleato, che ricorreva a veri e propri crimini con la scusa del mantenimento dell’ordine. La fotografia vintage, l’utilizzo straniante dei Kinks e dei Creedence nella colonna sonora e un cast in parte, in cui troneggia il comico Guillermo Francella nei panni del pater familias glaciale e privo di rimorsi, contribuiscono a dare al film la forza di una grande saga d’epoca, capace di conciliare, con notevole padronanza, un’onesta denuncia sociale e uno spettacolo avvincente e di facile fruizione anche da parte del pubblico internazionale.
Scorre in tutt’altra direzione The Endless River di Oliver Hermanus, primo film sudafricano di sempre a concorrere per il Leone d’oro. Un’opera dalle buone premesse, ma dal rendimento deludente. L’intenzione è quella di girare un melodramma di stampo classico attraverso la vicenda di tre personaggi – il francese Gilles, il gangster di colore Percy e sua moglie Tiny – coinvolti in una duplice tragedia familiare nel Sudafrica contemporaneo, ma il regista gioca nel peggior modo possibile le pur ottime carte che sembra avere in mano. L’interesse nei confronti dei tre protagonisti, persi in una fiacca sceneggiatura che zoppica fin da metà film, svanisce presto, i loro rapporti non si evolvono, e ci si trascina stancamente fino alla fine senza arrivare a nessuna conclusione. Anche l’analisi sociologica dell’entroterra sudafricano – dipinto come una terra di feroce violenza, nella quale la separazione fra bianchi e neri è ancora radicata – rimane inevitabilmente in superficie. La regia di Hermanus denota un certo talento visivo e sembra ispirarsi, fin dai titoli di testa, alla Hollywood anni Cinquanta, con riprese del paesaggio di ampio respiro che richiamano lo stile di John Ford, gli attori se la cavano (su tutti Nicholas Duvauchelle), ma tutto questo non è sufficiente a sopperire alla debolezza narrativa, lasciando nello spettatore il proverbiale amaro in bocca.