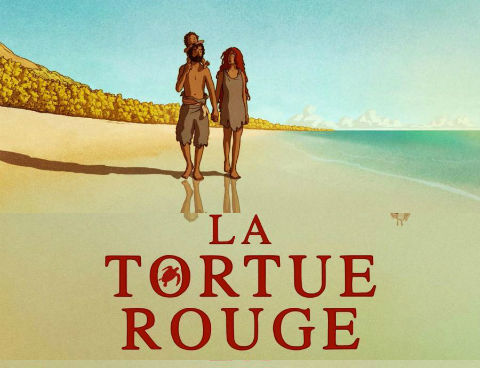Quando c’era Berlinguer: la recensione
L’esordio dietro la macchina da presa del da sempre grande amante del cinema Walter Veltroni è dedicato all’icona delle icone della sinistra italiana: lo storico segretario del P.C.I. Enrico Berlinguer, assunto per un’intera cultura politica – non necessariamente aderente in toto alle sue ideologie – al livello di mito per un senso di appartenenza storica, politica, morale e culturale. E come tutti i miti ingessato in un idealismo che semplifica, spesso interpreta strumentalmente e relativizza la grandezza della figura. Era questo il rischio principale a cui l’ex segretario dei D.S. e del P.D. andava incontro: fare i conti, oltre che con la vicinanza politica e umana, con il peso ingombrante della mitologia, cioè equilibrare l’inevitabile e sacrosanta partecipazione emotiva con una visione storico/politica più profonda e non risaputa. Quando c’era Berlinguer (prodotto da Sky Cinema) è infatti come se contenesse due film: quello d’impatto emotivo, efficace, e quello di resoconto storico-politico, da cui era lecito aspettarsi qualcosa di diverso.
Veltroni è un bravo affabulatore e un bravo narratore; anche con quel certo non so che di ruffiano, con un’innegabile retorica e mischiando opere, autori, esperienze diverse sa come colpire le corde giuste. Lo si vede anche in questo suo esordio alla regia, dove riesce a fra trasparire l’affetto verso la storica figura, e dove riesce a creare un certo impatto emotivo, da cui, a prescindere dal credo politico, non è facile rimanere immuni. L’ex sindaco di Roma parla col cuore e al cuore, e lo fa traducendo in immagini sul grande schermo quel suo stile che tante volte abbiamo sentito nei comizi, nei discorsi politici e letto nei suoi libri (i primi perlomeno, non certo capisaldi della letteratura, ma neanche da buttar via). Uno stile accomodante e pacificatore e allo stesso tempo aggressivo nella sua retoricità controllata ma esplicita, in cui non si capisce mai quanto e cosa sia sincero (e in questo film sicuramente la sincerità è molta) e quanto e cosa sia più ruffiano. Ne è un esempio la scena che anticipa i titoli di testa: la macchina da presa parte dalla superficie di Piazza San Giovanni deserta, fotografata con uno stilizzato bianco e nero, dove svolazzano pagine di giornali abbandonate (quelle de L’Unità del giorno dei funerali del segretario) per poi, all’inizio gradualmente e poi sempre più velocemente, alzarsi fino a sopra la basilica, da dove si vede la panoramica dell’intera piazza, col sottofondo di una musica solenne: in quel punto uno stacco di montaggio improvviso, reso ancora più calzante dal climax della musica, ci porta alle celebri immagini di quel 13 giugno 1984 che fotografavano l’enorme adunata dei funerali (oltre un milione di persone), ripresa da un elicottero dallo stesso identico punto. In questa scena – potente, retorica ed efficace – c’è tutta la capacità affabulatoria ed emotiva del politico-regista. Emotività che continua per tutta l’opera, raggiungendo il culmine nella quasi insostenibile scena dell’ultimo comizio, tenuto poco prima di entrare in coma. L’affetto traspare dalle parole dello stesso regista, voce narrante e commentatore, e dalle testimonianza di colleghi e amici (di Berlinguer e di Veltroni), così come ben dosate sono le immagini di repertorio e gli inserti cinematografici.
Se non si rimane immuni e un po’ inevitabilmente si cade nella trappola dell’emozione, più razionalmente lo spettatore che si aspettava anche un documentario storico/politico resta più deluso: da questo punto di vista Quando c’era Berlinguer non toglie e non aggiunge nulla alla figura del segretario. Se viene sì evitata l’agiografia più palese e sfacciata, non si va però oltre alla riproposizione, per quanto sommessa e amara, del “mito Berlinguer”. Intendiamoci, per evitare equivoci da bar della politica: qui nessuno si aspettava, né voleva, una visione revisionista o critica (anche perché considerato il regista non avrebbe avuto alcun senso logico), né che si mettesse in discussione una figura che anche molti avversari politici (vedi Almirante, per fare l’esempio citato nel film) hanno stimato e considerato in qualche modo grande. La questione come accennato all’inizio è che il mito, soprattutto quando è un mito della storia, ingessa e semplifica, chiudendo in un sepolcro imbiancato figure che, senza negare la loro grandezza, avrebbero diritto ad una visione più approfondita e combattuta, diversa dall’idealizzazione che spesso, in realtà, porta alla strumentalizzazione a posteriori. Considerato il curriculum del regista era quindi lecito attendersi almeno qualche accenno di analisi più scandagliata, qualche omissis in meno (il rapporto con i movimenti del ’77) e qualche punto in cui sarebbe stato interessante approfondire e aprire discussioni (la guerra col PSI craxiano, ma anche l’arroccamento del segretario successivo al caso Moro). Era l’occasione per scardinare qualche luogo comune e qualche convinzione radicata in una certa sinistra, ma anche qui Veltroni ha preferito non mettere in discussione nulla, mancando di coraggio nel volere navigare in acque sicure. Senza contare che alcune testimonianze lasciano qualche dubbio sulla loro utilità: perché dare spazio a Franceschini, il fondatore delle B.R., per autoassolversi? E poi Jovanotti, cosa c’entra?
È vero che probabilmente il neo-regista voleva semplicemente mettere in scena un diario sentimentale – e, ripetiamolo, da questo punto di vista il film funziona – ma è altrettanto vero che la sua storia, le sue conoscenze e le sue esperienze davano diritto ad aspettarsi un substrato storico-politico più potente, originale e approfondito. Ci si commuove, si ribadisce giustamente l’assoluta statura dell’uomo, ma si esce dal cinema senza saperne né più né meno di prima e senza che null’altro al di fuori dell’emozione si sia mosso. Non è poco, ma poteva esserci di più.
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
Regista: - Sceneggiatore:
Cast: