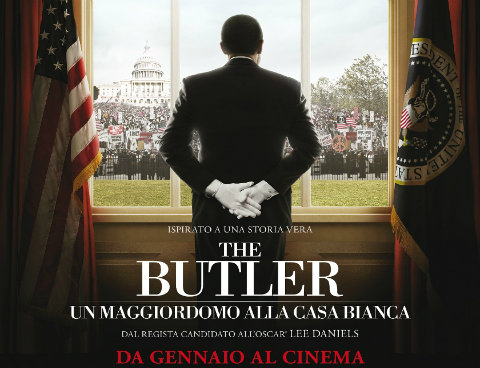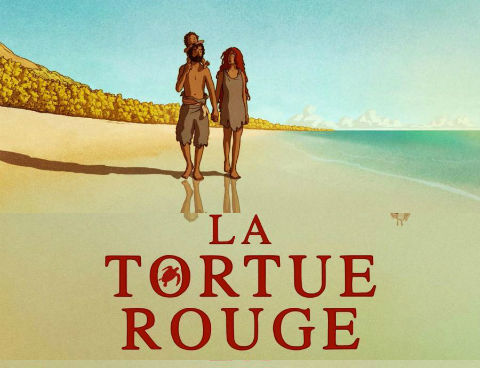The Butler: la recensione
“Parlano dei campi di concentramento, ma i campi di concentramento li abbiamo avuti per duecento anni anche qui negli Stati Uniti”, denuncia il vecchio Cecil Gaines, per quasi trent’anni maggiordomo alla Casa Bianca nell’ultimo film di Lee Daniels The Butler con Forest Whitaker, ispirato alla figura realmente esistita del maggiordomo Eugene Allen.
Sono i campi di cotone dell’Alabama, dove Cecil bambino vede freddare con un colpo di pistola alla testa il suo papà, colpevole di aver osato protestare dopo lo stupro della moglie a opera del padrone bianco. Dai campi di cotone, Cecil passa alle tavole apparecchiate e cariche di argenteria della casa colonica, dove la sua padrona lo educa a diventare un “negro di casa”, un perfetto servitore. Insegnamenti che torneranno utili quando il giovane Cecil lascia la piantagione e si avventura al nord, dove diventa cameriere in un importante albergo di lusso. Qui viene notato dal capo del personale della Casa Bianca, che ben presto lo assume come maggiordomo del Presidente degli Stati Uniti d’America, Eisenhower. A quest’ultimo, seguiranno altri sei capi di stato che tenteranno chi per convinzione, chi per interesse, di eliminare le disuguaglianze fra bianchi e neri. Cecil assiste allo spettacolo della storia da dietro le quinte, e diviene testimone privilegiato dei più grandi avvenimenti storici del proprio Paese, come l’omicidio di Kennedy. Dedito al proprio lavoro, fedele alle necessità della famiglia del presidente, Cecil trascura la propria la moglie (una Oprah Winfrey nel ruolo consolidato della donna di colore con gli attributi), che si dà all’alcool, e disapprovando il figlio Louis, che lotta per il riconoscimento dei diritti dei neri. Distanze che si colmano mentre seguono nuove fratture pronte a rinsaldarsi grazie all’amore e al dolore, come in tutte le famiglie.
Perché, in fondo, questo film è la storia di una famiglia con un padre speciale, visto che può sapere quante scarpe ha nel suo armadio la First Lady, o assistere ai momenti più privati del presidente Johnson, che lascia la porta aperta mentre è seduto sul water per poter parlare ai propri collaboratori e farsi passare da Cecil un’altra dose di lassativo. E’ in questi momenti comici che il film ha un’accelerazione che rompe la monotonia del ritmo. Nonostante le situazioni storiche e private siano molteplici, la cocciutaggine del personaggio di Cecil, l’irremovibilità dei suo convincimenti, la sua fissità coinvolgono e determinano anche l’andamento della storia, che resta piuttosto piatta. Forest Whitaker può fare poco per animare un personaggio statico, che subisce l’azione, piuttosto che crearla. Non è comunque questione di picchi narrativi che, al contrario, sono presenti: Louis, con la sua ribellione al modo di pensare di Cecil, per cui i neri possono sopravvivere solo con due facce, una per servire i bianchi e “far nascere un sorriso nei loro occhi” e l’altra per quelli del loro gruppo, genera una serie di climax narrativi che spesso corrispondono ai climax storici della lotta degli Afro-americani. Insomma, non sono le azioni a mancare, ma una visione che vada a fondo e che si concentri sull’essenziale. Invece qui il respiro è corto proprio perché tenta di essere eccessivamente ampio, in quanto si affanna ad abbracciare troppe tappe importanti della storia americana degli ultimi sessant’anni, lasciando inevitabilmente a casa due presidenti (Ford e Carter). Tutto si sfilaccia perdendo di definizione e impatto: il tema razzista che poteva, da solo, essere al centro della storia, diviene uno sfondo sul quale far svolgere le vicende familiari dei Gaines, e nemmeno la trasformazione del personaggio di Cecil, all’inizio un conservatore cieco e timoroso, o il cast stellare e polifonico con star del mondo della musica, del cinema e della televisione, riescono a salvare un film con delle ottime intenzioni, ma che ha voluto dire troppo senza averci lasciato molto.
Scritto da Vera Santillo.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
Regista: - Sceneggiatore:
Cast: