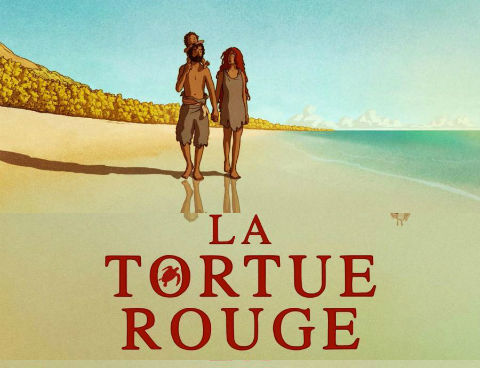TFF 2013 – Inside Llewyn Davis: la recensione
E’ un’occasione d’oro la visione di Inside Llewyn Davis dei fratelli Coen, vincitore del Grand Prix all’ultimo Festival di Cannes, al Torino Film Festival; e ci sta benissimo in questa trentunesima edizione impreziosita dalla retrospettiva sulla New Hollywood, testimonianza della straordinaria epoca di fermento e sperimentazione che sono stati gli anni Sessanta. Inside Llewyn Davis si colloca agli albori del decennio, ne carpisce certe atmosfere, si sostiene su molta bella musica (le canzoni originali sono di T Bone Burnett), e sceglie di raccontare il punto di vista di un perdente.
E’ il 1961 e Llewyn Davis è uno spiantato musicista folk che bazzica i palchi underground di New York: non ha una casa, tenta di sfondare, come tanti. E’ bravo, ma sembra che tutto il mondo preferisca sempre quello accanto; è inaffidabile ma non cattivo, eppure riesce a farsi detestare con facilità.
Il rancore rassegnato, l’incapacità di progettare, la disattenzione, la vita alla giornata hanno almeno in parte una causa riconoscibile (o una comoda scusa): Llewyn è rimasto privo della sua metà musicale, il sodale Mike, e questa incompletezza sembra renderlo incapace, soprattutto agli occhi esterni, di riconfigurare la propria esistenza e la propria identità. Nessuno lo apprezza come solista (nonostante, a chi guarda, sembri avere tutte le caratteristiche a posto: il contrasto tra la bravura dell’ignorato Llewyn e i più modesti e melensi interpreti di successo che lo circondano è uno dei canali attraverso cui si esprime la surrealtà ironica coeniana), e Llewyn fatica a distinguersi tra i tanti epigoni che frequentano la scena blues-folk: anche il collega Al Cody (Adam Driver) ha uno scatolone di dischi invenduti dalla copertina con immancabile fotografia di vagabondaggi. Non importa che scelte faccia, quale posto letto scrocchi, dove suoni, Llewyn va sempre a sbattere contro pareti immaginarie che gli impediscono di smarcarsi dal proprio status quo: il perimetro è mobile, va da un vicolo dei bassifondi, al volto impenetrabile di F. Murray Abraham, dalla notte nera punteggiata di neve, al mare come ultima e disperata alternativa, bloccata anch’essa da kafkiani intrecci burocratici. Anche nei rapporti interpersonali si attorciglia sempre sugli stessi errori (i guai con le ragazze, la sorella, il padre) e si ritrova lasciato costantemente e letteralmente a piedi. Sullo sfondo una New York sentimentale, perfetta fotografia della contraddizione di un mondo che inizia a muoversi verso cambiamenti epocali, con l’eventualità sempre dietro l’angolo di rimanere immobili, nonostante gli sforzi, dimenticati dalla fortuna e dalla Storia, mentre essa ci passi davanti al naso (si veda la sorpresa dell’ultima sequenza).
Inside Llewyn Davis è privo dello humour nero folgorante e del distacco cui altre volte i Coen ci hanno abituati, ma si stratifica assumendo come collante una costante malinconia per qualcosa che non è e non sarà: si traveste da commedia, diverte con certi caratteri secondari e certi dialoghi; poi diventa disperato, e intanto è film musicale e road movie; si astrae infine in una voluta ambiguità, la cui percezione è l’ironico e definitivo guizzo di consapevolezza del protagonista. Ottimi tutti gli interpreti, dall’inviperita Carey Mulligan, a Justin Timberlake, fino al decadentissimo John Goodman. Eccezionale la prova di Oscar Isaac, che ha il volto perfetto per incarnare il déja-vu del fallimento.
Un film maturo sul fraintendimento dei segni e dei desideri, su un gatto che ama viaggiare, sulla routine che si trasforma in indecidibile circolarità da cui non si scappa, e che finisce per inceppare questa versione del sogno americano.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Alice C. | Barbara N. | Davide V. | Edoardo P. | Giacomo B. | Giusy P. | Sara M. | Thomas M. | ||
| 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast: