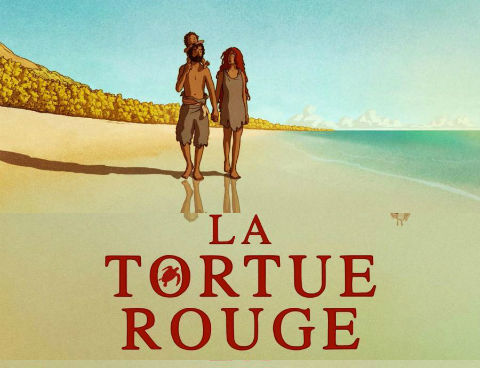Roman Polanski – La trilogia dell’appartamento
Casa. Ciò che più dovrebbe essere heimlich, rassicurante, intimo, fidato – letteralmente “proprio della casa” – si rivela unheimlich, estraneo, segreto, misterioso. Così come il pensiero, la memoria, il rapporto con l’altro e gli oggetti della quotidianità: pilastri instabili su cui costruire esistenze incerte, una normalità puntellata con legno fradicio e un palcoscenico , l’appartamento, in cui tutto si sgretola.
Come Roman Polanski sia arrivato ad una traduzione cinematografica così suggestiva e puntuale degli inganni della mente è argomento che ha affascinato molti, a partire dalla prima proiezione di Repulsion nel 1965.
Normalmente si ha la certezza di una sedia e la certezza di potercisi sedere. Ma se non si ha più questa certezza e ci si siede di colpo in un immenso vuoto tutto diventa terrorizzante.
Osservazione, questa, tratta da un’intervista allo stesso Polanski che, insieme al monologo di Trelkovsky ne Le locataire, riassume appieno tutto il senso della riflessione polanskiana sull’identità e sulla consistenza della realtà, due piani legati in modo inscindibile: ad un’identità psichica e corporea scissa corrisponde infatti un mondo a pezzi, confuso e impossibile da decifrare se non attraverso la lente distorta della paura e della proiezione paranoide. Rosemary, Carol e Trelkovsky, con modalità diverse, sono uniti in questo percorso di regressione e di ritiro su di sé in risposta ad una realtà e a relazioni oggettuali avvertite come minacciose e mortifere.
Certo le differenze sono tante e si va da una situazione come quella di Rosemary’s Baby in cui l’intervento del soprannaturale è conclamato, a quella de L’inquilino del terzo piano più marcatamente sbilanciata in chiave psicologistica – laddove il testo di Topor da cui il film è tratto è molto più magico ed esoterico, non a caso lì le locataire è chimérique –, fino a quella dichiaratamente psicotica di Repulsion. Ma se Polanski, parlando di Rosemary’s baby, sottolinea con ironia come gli spettatori, alla fine del film, siano convinti di aver visto il Diavolo, quando invece niente del genere è mostrato in modo inequivocabile, non è solo per evidenziare i meccanismi di suggestione che coinvolgono il pubblico: anche qui il Male può essere visto come un semplice simbolo e il regista è di certo più interessato a seguire il percorso di involuzione della sua protagonista che lo svolgersi degli eventi esterni, siano essi effettivi o frutto di una percezione distorta. Satana, come simbolo di metamorfosi, ambiguità e ambivalenza, si presta a rappresentare il conflitto psichico: un’invasione del Male che rispecchia l’emorragia dell’Essere.
Le tappe si ripetono così come le dinamiche e gli oggetti rivelatori, primo fra tutti lo specchio, presenza incombente soprattutto nell’appartamento di Monsieur Trelkovsky. Lo specchio rivela ai protagonisti una consistenza corporea incompresa – una gravidanza rifiutata, una sessualità irrisolta, una trasformazione che si crede indotta ma viene dall’interno -, insomma l’estraniante familiarità del corpo, quella sedia su cui non si è più certi di potersi sedere. La macchina da presa sottolinea questo passaggio soffermandosi con insistenza su ciò che è più fisico e quindi corrotto, come il coniglio che va putrefacendosi in Repulsion, o il cratere vuoto della bocca di Simone, elementi di realtà che si contrappongono alla regressione narcisistica e idealizzante dei protagonisti.
Una regressione inconsapevole, vissuta come un’esperienza angosciosa di perdita d’identità inaccettabile a meno che non venga avvertita come proveniente dall’esterno e permetta quindi di scaricare la tensione attraverso la risposta paranoide. E il vicino di casa, al cinema e nella realtà, incarna alla perfezione il doppio persecutorio, così come lo spazio interno dell’appartamento è sia labirinto sia organismo vivente carico di ricordi e emozioni. La tensione cresce, così come le spinte aggressive e il senso di ineluttabilità degli eventi. Con un finale tragico. Monsieur Trelkovsky per trovare pace dovrà mettere in scena il suo doppio suicidio davanti agli esterrefatti condomini (mentre l’indeterminatezza del linguaggio permette a Topor di delineare un quadro molto più incerto: “il corpo di Trelkovsky volò dalla finestra” e non si gettò); Carol ucciderà per poi tornare tra le braccia della sorella-madre mentre l’inquadratura scivola su una foto di famiglia, su quel padre amato e distante; Rosemary forse accetterà il male che è cresciuto in lei, fino ad allora rigettato ma di più non è dato sapere.
“Dimmi, in quale preciso momento un individuo smette di essere quello che crede di essere?” Confine liquido che Roman Polanski non ha mai smesso di indagare attraverso l’immagine filmica, la codificazione in simbolo e metafora, la ricreazione di uno spazio, reale e allucinato al tempo stesso, che è quello del cinema come quello del sogno.
Scritto da Barbara Nazzari.
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.