La La Land, un altro giorno di sole (forse)
Emma Stone e Ryan Gosling protagonisti del secondo film di Damien Chazelle

In qualche modo La La Land, secondo film di Damien Chazelle, è già entrato nella storia del cinema grazie al record di nomination agli Oscar; ben 14, come nella storia han fatto solo Eva contro Eva e Titanic. Il tempo dirà se ci entrerà anche per meriti meno glamour e più strettamente cinematografici; però, questo è quello che speriamo e crediamo, almeno a caldo e mentre fischiettiamo le melodie di Someone in the Crowd o di City of Stars e quelli più temerari di noi rischiano qualche acuto.
La La Land è sì un film “divertente” e dall’innegabile impatto emotivo e dall’altrettanto evidente coinvolgimento più immediato; ci si emoziona per la storia d’amore tra la giovane aspirante attrice (Emma Stone, già Coppa Volpi) e l’aspirante e nostalgico pianista jazz (Ryan Gosling) e ci si lascia rapire dalle canzoni e dalle melodie composte da Justin Hurwitz; il valore del film non sta però “tutto” qui, e l’equivoco nato sull’idea che il film sia un ingenuo film sul potere dei sogni lo dimostra. Il sogno, inteso – per semplificare – come concetto d’incanto, meraviglia e di fuga dalla realtà tipico del musical è certamente un significato fondamentale. Lo stesso titolo che rimanda a Los Angeles, la più tipica città dei sogni e delle illusioni, e il fatto che protagonisti siano un’aspirante attrice e un aspirante musicista lo dimostrano. Questo aspetto però non è tradotto in maniera ingenua e all’insegna del lieto fine e della felicità a tutti costi.
È certamente trasmessa come in ogni musical che si rispetti, anche in quelli più stratificati, la “joie de vivré”, ma la forza principale di La La Land è in realtà il suo sottofondo malinconico e disincantato, espresso anche, per esempio, dalla maniera un po’ impacciata con cui i pur brav* Stone e Gosling ballano e cantano, esprimendo così le insicurezze, le illusioni e le paure dei personaggi. È un film che più che del sogno parla dell’illusione, del sacrificio e delle scelte dolorose e necessarie per raggiungere un obiettivo e della necessità amara di rinunciare a qualcosa e a una parte di sé. E nello splendido, amarognolo e minnelliano finale fa pure capolino il rimpianto. Il sogno e l’incanto tipici del musical vengono così, in fin dei conti, intesi come rielaborazione di sacrifici e rinunce, o come arma con cui combattere per un obiettivo ancora lontano senza lasciarsi soccombere dalle relative paure.
Chazelle, realizzando un film certamente derivativo, ma che allo stesso tempo non dà l’impressione di essere puro esercizio di citazioni, rielaborando i modelli in maniera efficace, si ispira in parte sì al musical statunitense degli anni ’50 (c’è Vincente Minnelli e c’è un’atmosfera simile a E’ sempre bel tempo, non a caso il film meno allegro della trilogia realizzata da Stanley Donen e Gene Kelly), ma soprattutto al francese Jacques Demy. C’è infatti la stessa malinconia di fondo e molto simile è il concetto dell’incanto come rielaborazione di infelicità, perdite e rinunce. Lo fa confermando la sua capacità di raccontare la musica al cinema e la sua regia elegante e quasi barocca, capace di regalare – si veda il piano sequenza iniziale sulle note di Another Day of Sun – momenti di grande cinema puro.
| Edoardo P. | Chiara C. | Davide V. | Ilaria D. | ||
| 8 | 8½ | 7 | 9 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast:



























































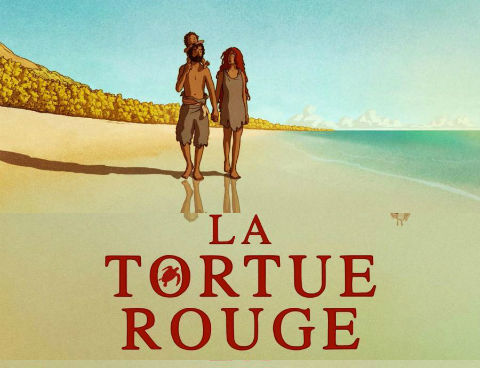











































C’è anche qualche top shot non totalmente berkeleyano, ma comunque gradito!