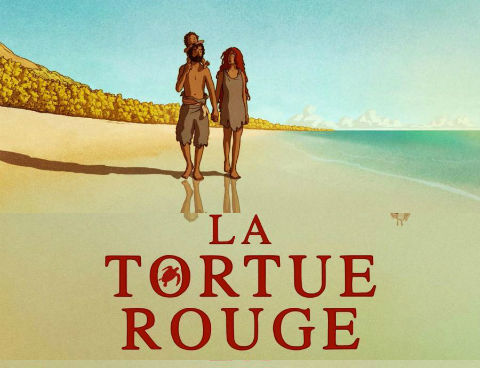600 millas: la recensione
Il debutto di Gabriel Ripstein sceglie la via psicologica per armare una resa dei conti minimale

Niente fuochi d’artificio, ma poche cartucce ben assestate nel minimale thriller d’azione 600 millas, con cui il messicano Gabriel Ripstein, al debutto, racconta l’implosione di un cartello delle armi al confine meridionale degli Stati Uniti. La coppia che scoppia è quella formata dai due baby gangster Arnulfo (Kristyan Ferrer) e il suo fornitore americano, Carson (Harrison Thomas), impegnati a mascherarsi di facce d’angelo per comprare un pugno di armi da smerciare in Messico. La dinamite silenziosa è l’agente dell’ATF Hank Harris (Tim Roth), che li pedina, ma diventa scomoda pedina non appena scoperto. Scomoda come un bagaglio ingombrante da trasportare per 600 miglia.
Presentato a Berlino nella sezione “Panorama”, il film di Gabriel Ripstein, a proposito d’armi, sa giocare di sciabola e fioretto, mostrando sia il confine violento che il conflitto interiore, sia lo scontro fisico che il duello mentale. Da un lato, infatti, il film si prospetterebbe come un crudo ed essenziale docu-drama, stilizzato e poco sensazionalistico (basti confrontare lo scoppiettante, esagerato Sicario con Benicio Del Toro), ma carico di aggressività latente; dall’altro, anche nella fase di più esacerbata accelerazione, il film pare giocato per lo più sulla tensione dell’ambiguo e mutevole rapporto preda-predatore tra il giovane criminale Arnulfo e lo scafato agente Harris.
Che 600 millas sia un film drammatico camuffato da film d’azione, è confermato dal calibrato lavoro alla macchina da presa di Alain Marcoen, regolare collaboratore dei Dardenne. Assai indicative, in questo senso, due sequenze lunghe che vanno dritte al bersaglio: una in camera fissa, mentre Arnulfo discute con lo zio boss, mentre sull’agente pende la spada di Damocle, e l’altra, più dinamica ma sempre parca di tagli al montaggio, in cui detona una sparatoria d’interni. Tutt’altra cosa rispetto alle rese dei conti hollywoodiane e a tanti classici “Mexican standoffs”.
Se Tim Roth lavora d’esperienza, in un ruolo monolitico che interpreta con solidità da veterano ma con un pizzico di prevedibilità, il giovane Ferrer diventa il vero protagonista, operando al confine tra durezza e fragilità e consentendo quella coloritura emotiva che rinsangua a dovere una storia altrimenti leggerina. Gli 85 minuti scarsi raccontano di una scelta di essenzialità quasi scarnificata, che in effetti cede qualcosa sul piano dell’adrenalina. Pure, un’indovinata sequenza finale d’un cinismo secco che riecheggia Non è un paese per vecchi, mentre scorrono i titoli di coda, lascia intendere la chiave psicologica del film, un profilo basso la cui efficacia al silenziatore è preferibile allo spettacolo chiassoso.

| Antonio M. | ||
| 7 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast: