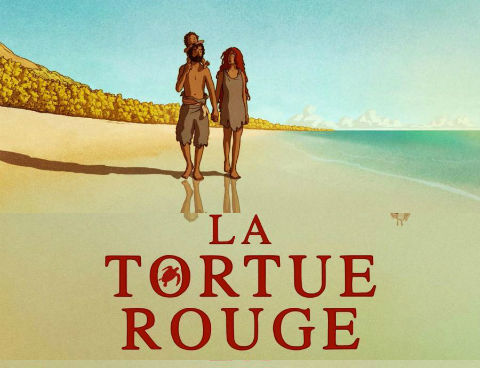Grand Budapest Hotel: la recensione
Grand Budapest Hotel è poesia della comicità. Vincitore del Gran Premio della Giuria alla 64^ Berlinale, l’ultimo film di Wes Anderson conferma la caratura dell’autore de I Tenenbaum, capace di incantare anche con un film più, in un certo senso, “fine a sé stesso” rispetto ad altre sue grandi opere passate, altrettanto divertenti ma anche più ancorate a una sarcastica e laconica rappresentazione di un certo disagio culturale, interiore e di costume.
Andare al cinema, sedersi sulla poltrona e guardare Grand Budapest Hotel è navigare nell’astrattezza pura dell’umorismo e della narrazione, è come viaggiare in un passato reinventato ma plausibile, è come addormentarsi ed entrare in un mondo di sogno creato e popolato dalle firme stilistiche più tipiche del regista, qui quasi esasperate, ma che mai paiono eccessive o fastidiose: gli accesi colori pastello, la fantasia degli ambienti che crea straniamento, le carrellate orizzontali, le atmosfere fiabesche – evidenti nei molti scenari disegnati e dipinti – e la stravaganza di situazioni e personaggi.
Si viene trasportati in un altrove magico e fittizio, eppure, come accennato, quasi plausibile: la vicenda si svolge nella fantomatica repubblica europea di Zubrowka nel periodo precedente allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale (i fatti storici sono essi stessi reinventati, ma dai riferimenti più che palesi). Il Grand Budapest Hotel è un importante e rinomato albergo situato su una montagna, dove lavora Gustave H. (Ralph Fiennes), concierge raffinato, carismatico, un po’ pomposo e conquistatore di anziane dame dell’alta società europea. Insieme al giovane tuttofare Zero (Tony Revolori), a seguito alla contesa sull’eredità lasciata da una delle dame da lui ammaliate, entra in un intrigo fatto di quadri rubati, sparizioni, uccisioni e fughe, parallelamente ai venti di guerra che sempre più forte iniziano a soffiare sul continente. Il rapporto tra il concierge e il giovane tuttofare diventerà sempre più stretto, finendo per assomigliare a un rapporto padre-figlio.
La rappresentazione dell’Europa immaginata e reinventata dal regista, il quale visivamente si è ispirato soprattutto all’iconografia della Belle Epoque, appare intrisa di nostalgia e di rimpianto per un mondo conosciuto solo indirettamente attraverso libri, canzoni e immagini, e che perciò Anderson immortala sullo schermo come se stesse raccontando una dolorosa utopia o una fiaba; un mondo che stava tirando gli ultimi respiri prima di essere spazzato via dalla tragedia della guerra e del nazismo, i cui protagonisti saranno, non a caso, i cattivi del film (Adrien Brody e Willem Dafoe). In quest’ottica matura, quel sottofondo malinconico e amaro che è un’altra firma tipica dell’autore, qui sommesso ma costante. La poesia della comicità di cui abbiamo parlato all’inizio diventa quindi anche un canto elegiaco per un mondo che Anderson ha indirettamente imparato ad amare, sognare e idealizzare, e che fondamentale è stato per la sua formazione culturale, come lui stesso ha più volte dichiarato. Questa lettura rende ancora più straniante la comicità, e rende Grand Budapest Hotel un film leggero, patinato, volutamente estetizzante nei suoi toni pastello, ma tutt’altro che frivolo e spensierato, al tempo stesso spassoso, malinconico ed elegiaco.
Del resto europei sono gli autori che hanno ispirato il film; non solo lo scrittore austriaco Stefan Zweig, i cui racconti sono alla base dell’opera, ma anche il tedesco maestro assoluto della commedia cinematografica: il grande Ernst Lubitsch. L’influenza del capostipite della comedy è evidente non solo perché il film è ambientato nell’Est Europa simile alla mitteleuropa sfondo di molte commedie anni Trenta, ma anche per la centralità dell’inganno e della finzione e per la frivolezza più apparente che effettiva. È anche vero che il film è talmente affascinante a livello visivo, talmente coinvolgente a livello narrativo che conquista solo per il puro e immediato piacere della visione, rendendo quasi superflua qualsiasi ulteriore lettura. Decenni dopo l’ancora irraggiungibile “Lubitsch’s Touch”, ora possiamo metterci comodi in sala e farci conquistare dall’”Anderson’s Touch“.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Alice C. | Chiara C. | Davide V. | Sara M. | Thomas M. | ||
| 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast: