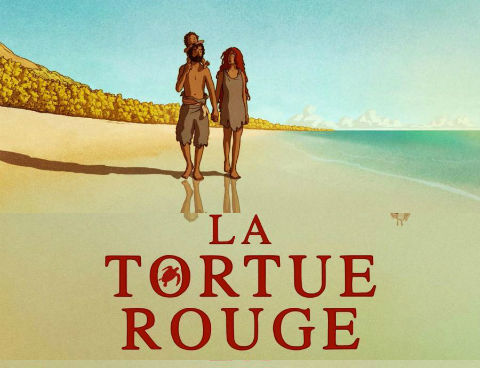12 anni schiavo: la recensione
L’opera terza del video-artista inglese Steve McQueen, 12 anni schiavo, è tra i favoriti dell’imminente serata di consegna degli Oscar, forte delle 9 nomination ricevute. 12 anni schiavo è anche, in qualche modo, il film che segna il passaggio del regista inglese da una visione “autoriale” e “personale” tout court a una visione sempre molto personale, ma allo stesso tempo maggiormente inserita nei canoni dell’industria cinematografica americana più mainstream. Opera quindi di passaggio, probabilmente decisiva per la strada che il regista intraprenderà d’ora in poi. Inoltre, date le aspettative e considerato il tema caldo, il film è partito già assumendo uno status di culto preventivo, come fosse già scritto che sarebbe stato il film definitivo sullo schiavismo statunitense, e come fosse inevitabile il fatto che ci saremmo trovati di fronte a un capolavoro. In realtà, è proprio, come cercheremo di spiegare meglio più avanti, per l’ancora acerbo e perfezionabile amalgama tra la forte personalità registica e una maggiore, chiamiamola così, convenzionalità di fondo che 12 anni schiavo non convince appieno, apparendo certamente un buon film, ma non il capolavoro che molti dicono.
Alla base dell’operazione c’è l’omonima autobiografia scritta nel 1853 da Solomon Northup (interpretato da Chiwetel Ejiofor), cittadino di colore dello stato di New York ingannato, derubato della libertà e mandato come schiavo nei campi della Louisiana; la sua odissea durerà 12 anni, passati prima agli ordini di un padrone buono ma inerme (Benedict Cumberbatch), poi nelle piantagioni del crudele e psicopatico Edwin Epps (Michael Fassbender), dove viene a contatto con i più profondi abissi della cattiveria e della violenza insiti nella “peculiare istituzione”. L’incontro con un convinto abolizionista canadese (Brad Pitt, il quale, permetteteci, da quanti anni non cambia espressione del volto?) permette a Solomon di rendere nota la propria storia, recuperare la libertà rubata e tornare dalla famiglia, ovviamente col peso insostenibile delle violenze e dei soprusi visti e subiti in questi 12 anni.
12 anni schiavo, così come Hunger e Shame, trova la sua linfa vitale nella rappresentazione dei corpi martoriati e delle assuefazioni contro cui sbatte, perdendosi, l’interiorità e l’anima dei protagonisti: quello di McQueen è quindi un cinema che ha trovato e trova la sua forza dirompente nella potenza della rappresentazione, capace di assumere un’affascinante connotazione quasi metafisica. I momenti migliori di 12 anni schiavo sono proprio quelli che mostrano più chiaramente le conseguenze fisiche e morali della schiavitù sul corpo e sull’anima del protagonista e degli altri schiavi, quelle in cui la mano dell’autore si fa sentire con maggiore prepotenza. Per fare un esempio, la già giustamente celebre, e già citata da molti, sequenza di circa tre minuti in cui il protagonista, abbandonato con una corda al collo, lotta a punta di piedi contro il fango per non scivolare e non morire impiccato. Sequenza che è una magistrale lezione di regia, certo non l’unica presente nel film. Se però nelle due opere precedenti questa potenza di sguardo creava essa stessa il senso dell’opera e l’empatia nei confronti dei personaggi, in questo caso non è abbastanza continua da riuscire a fare altrettanto, e allo stesso tempo non riesce ad amalgamarsi bene in una cornice più evidentemente tradizionale del racconto e della messa in scena. E’ un po’ come se McQueen fosse rimasto a metà del guado, realizzando un’opera non abbastanza radicale e “propria” nello sguardo, né efficacemente inserita in schemi più consueti.
Il paragone con altri film dedicati alla schiavitù più o meno recenti, la “trilogia” dedicata al tema da Steven Spielberg e Django Unchained di Quentin Tarantino, può essere una pietra di paragone significativa: in questi casi, gli autori sono riusciti a inserirsi abilmente in cornici offerte dall'”industria” senza perdere per nulla le proprie firme più riconoscibili e originali, realizzando opere, da questo punto di vista, più coerenti e centrate. L’opera terza di McQueen assomiglia un po’ a quelle torte in cui c’è un ingrediente delizioso e ghiotto, ma che non si lega bene con gli altri ingredienti, finendo per stonare. Da qui nascono certi difetti strutturali, come il mancato approfondimento di personaggi secondari, ma dall’enorme interesse psicologico, storico e morale, solo accennati: si pensi al capo carpentiere interpretato da un ottimo Paul Dano, simbolo della meschinità resa dal sistema schiavistico, norma nell’essenza dell’uomo sudista, o all’umanità di fondo della prima coppia di padroni sottomessa, però, al rispetto delle consuetudini e delle regole, così come alla rabbia crescente nella moglie di Epps, nata da motivi personali ma giustificata con l’inferiorità dei neri. Non manca anche, qua e là, un certo didascalismo di fondo, evidente nel personaggio interpretato da Brad Pitt (in questo caso, ricordiamolo, anche produttore).
Tutto ciò non toglie il fatto che il regista inglese abbia comunque realizzato un’opera di una certa importanza, fosse solo per la cruda e sincera rappresentazione della violenza che non fa sconti o per gli interessanti spunti di riflessione strettamente storiografica (a questo proposito consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo). Anche se questa volta non le ha giocate sempre bene, McQueen dimostra di avere tutte le carte in regola per confermarsi un grande della settima arte.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Alice C. | Davide V. | Giacomo B. | Thomas M. | ||
| 7 | 6 | 7 | 7 |