Un giorno devi andare: la recensione
Il mutismo a cui Giorgio Diritti costringe Jasmine Trinca nei primi dieci minuti de Un giorno devi andare, in selezione ufficiale al Sundance, è il silenzio del dolore che è sempre incomunicabile perché è esclusivo di chi soffre, mai condivisibile perché incrostato alle pareti intime di chi sta male. È la mancanza di dialogo fra le tre donne di una famiglia, è il mutismo a cui sono soggetti l’uomo e il tempo frenetico del dovere quando ci si trova in spazi sconfinati, quando la natura ci riporta alla condizione più basica e dunque più vera dell’essere umano. Eppure questo silenzio rimane implicito, distante, intrappolato nelle fredde montagne del Trentino, dove è ambientata parte della vicenda, e non giunge a toccare le corde intime dello spettatore che di fronte ai grandiosi paesaggi d’Amazzonia e alla genuinità della gente della favelas di Manaus prova una malinconia simile a quella di Gauguin di fronte agli abitanti di Tahiti, la nostalgia di ciò che si era in origine: un bambino curioso indivisibile dalla propria comunità. Ed è questo anelito verso un paradiso perduto, una società solidale e compatta, espresso del regista a salvare un film che ha dovuto sacrificare le proprie aspirazioni documentarie.
Eh sì, perché la storia di Augusta – che dopo aver perso un bambino, aver scoperto di non poterne più avere e il successivo crollo del suo matrimonio, segue suor Franca in Amazzonia per sfuggire al dolore o almeno trovargli un senso – non ci rapisce, non ci trascina nella carne viva della sua sofferenza. Una sofferenza che Augusta non è riuscita a comunicare nemmeno a sua madre Anna, ancora addolorata per la perdita del marito e troppo piena del proprio dolore per accogliere quello della figlia. Incomunicabilità che si ripete nel rapporto di Anna con la madre Antonia, nonna di Augusta, che visita di sfuggita solo per dovere, ma con la quale non riesce mai a parlare veramente.
La dicotomia caldo/freddo, calore umano/gelo del cuore, unione/lontananza, condivisione/distacco prende corpo attraverso l’alternanza fra l’esistenza, il viaggio interiore di Augusta in Amazzonia e la vita monotona e grigia della madre e della nonna in Trentino. Un’alternanza che non fa scorrere la scena precedente in quella successiva in maniera naturale, come le acque del Rio Negro nel Rio delle Amazzoni. Non si tratta di una fusione, ma di una cesoia che infastidisce, che stona, certamente non a causa del montaggio, ma di una sceneggiatura che non crea tensioni, che non ci fa entrare nel personaggio di Augusta, che ci tiene distanti. Distanti rispetto al dolore di Augusta, una Jasmine Trinca troppo musona e chiusa in se stessa, “una piccola donna complicata” come dice il suo stesso personaggio. Vicini, però, rispetto alla comunità di indios della foresta, alla natura selvaggia, alla semplicità di rapporti autentici basati sulla fratellanza e sul senso di appartenenza alla propria terra e al proprio gruppo.
Al contrario di quanto accadeva ne Il vento fa il suo giro, qui l’arrivo dello straniero non crea tensioni o squilibri: se lì la comunità veniva sconvolta dall’avvento dell’uomo di fuori che a sua volta subiva una metamorfosi, qui la favelas accoglie Augusta integrandola, ma non ne viene modificata. Il passaggio della donna non mette in discussione ciò che avviene quotidianamente fra le palafitte che continuano a cadere, dove i bambini continuano ad essere venduti e la partita di calcio del quartiere continua a svolgersi seguita dalla telecronaca de “La voce della palafitta” (un abitante seduto comodamente nella sua palafitta affacciata sul campo che commenta il gioco attraverso un megafono).
E sono questi elementi documentari, la realtà di queste immagini più di quelle ricercate e dal sapore pittorico del cielo che si rispecchia nel fiume, della spiaggia, dove una solitaria Jasmine Trinca pare essere sbarcata per partecipare a L’isola dei famosi, a emozionare e a coinvolgere. “Anche qui c’è la minaccia esterna verso la comunità”, ci tiene a sottolineare Diritti. È la minaccia del progresso che ha il volto degli imprenditori europei che vogliono costruire residence turistici e fare degli indios degli intrattenitori da cabaret che si esibiscono nelle loro danze. È la ricerca del benessere che ti fa vendere un bambino, è il governo che vuole distruggere le favelas, perché pericolose oltre che brutte, e sparpagliare la comunità dove “i bambini sono figli di tutti” e strapparla dalla terra degli affetti e dei padri.
Diritti ha voluto far recuperare allo spettatore occidentale questa dimensione primigenia e comunitaria attraverso la finzione. Ma questa si rivela superflua rispetto alla forza dell’immagine reale, all’impatto penetrante della vita, della realtà di cui il cinema si fa portatore sano e inevitabile.
Scritto da Vera Santillo.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Alice C. | Giusy P. | Thomas M. | ||
| 5 | 7 | 6 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast:




































































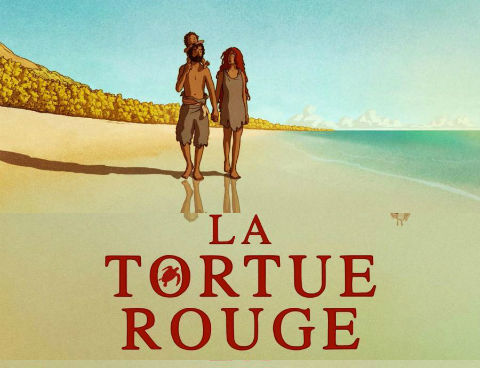










































Passo falso.Al terzo film Diritti inciampa alla grande.Immagini notevoli ma non bastano,troppi simbolismi troppa retorica,la storia non mi ha mai preso.Jasmine Trinca è brava però non basta secondo me.Il film mi è sembrato debole.Peccato perché i primi 2 film mi erano piaciuti parecchio,soprattutto l’esordio IL VENTO FA IL SUO GIRO.Spero che il suo prossimo film(eventuale) torni ai livelli dei primi 2 film.
@Annina e @Martina: un conto è parlare di immedesimazione in una storia/in un personaggio, un conto è il giudizio estetico sul film. E’ possibilissimo che un attore non interpreti bene una parte, ma che il personaggio (o la storia nella quale è inserito) risulti affascinante.
Qui c’è un po’ di arroganza.
Abbiamo due opinioni diverse sul film.
Come già detto, credo che il racconto nel film di Diritti ci sia, ma passi nel †œdescrivere† ancor prima che nel †œnarrare†, che cmq sia non manca considerando che la pellicola prevede tre fasi, di cui l†™ultima con un finale aperto, sospeso. Personalmente, per questo film, stai chiedendo al regista qualcosa che non era nelle sue intenzioni: il titolo stesso inquadra tutta l†™opera in un†™ottica di non-definizione che non può essere contenuta entro i paletti che tu vorresti…
Penso inoltre che Diritti non sia †œdiplomatico†, non è quel tipo di regista. I suoi film nascono da una necessità e non hanno bisogno né di mediare né di dare scossoni a nessuno. Il suo è un cinema che vola alto e sopra queste piccolezze…
Premettendo che la mia recensione parta da un punto di vista personale e che non è il Verbo, tengo però a precisare che:
– l’interpretazione della Trinca che ho definito troppo musona si inserisce perfettamente nell’atmosfera in perpetuo “sotto tono” del film che si riallaccia anche al gelo, all’apatia dei sentimenti del Trentino e che fa emergere invece in maniera sfavillante la gioia di vivere degli abitanti della favelas di Manaus e dell’Amazzonia. Jasmine Trinca non mi ha emozionato, il suo personaggio non permette a nessuno di accedere al proprio dolore e la recitazione dell’attrice riesce appieno nell’intento. Ma sono contenta di leggere che, invece, Annina si è rivista in lei e con lei ha scoperto una nuova serenità.
– Non cito tutti e due i film precedenti di Diritti e se leggi con attenzione, Tommaso, ho citato solo il suo lungometraggio d’esordio che mi ha convinto molto di più rispetto a quest’ultimo film per quella capacità di indagare l’essere umano messo davanti al nuovo, al diverso, alla minaccia che comporta ogni vero confronto. In questo film manca proprio la miccia che si accende quando due culture diverse, due o più identità vengono davvero a contatto.
E mi dispiace, ma in un film di finzione non mi bastano le immagini evocative, ci vuole il racconto insieme a personaggi complessi e coinvolgenti. Altrimenti punti sul documentario che comunque una sorta di bozza, di linea narrativa la prevede.
La sufficienza che ho dato dipende da questo. Ad essere stato “diplomatico” è Diritti che se voleva davvero dare uno scossone al nostro cinema anestetizzato, doveva osare e fare del suo film un documentario. Gli elementi li aveva tutti: sono quegli stessi elementi che salvano un film, per me, non pienamente riuscito.
Dici che la sceneggiatura non crea tensioni e non coinvolge. Non sono d’accordo. Diritti crea un film molto più complesso e stratificato dei due precedenti – che citi di sfuggita e quindi temo tu non abbia visto. La “tensione” c’è e si crea sulla lunga distanza, nell’attesa che è tipica del suo cinema, dove è la descrizione per immagini il vero motore del racconto. E’ un cinema insolito per noi italiani, e, piacendo o meno, merita di più di un risicato 6 che sa di politico e diplomatico. Io la penso così…
Ho visto il film e non sono d’accordo nel definire il personaggio della Trinca “troppo musona”. Detto così sembra che l’attrice non sappia interpretare il personaggio. Trovo che invece ci riesca molto bene, e che ci sia un notevole lavoro sulle espressioni del suo volto e soprattutto sull’uso del sorriso che, personalmente, ho trovato riuscito e coinvolgente.
ringrazio Giorgio Diritti per aver fatto questo film. sento Augusta tanto simile a me, anche io sono partita come lei per sconfiggere un dolore. Guardando il film ho scoperto una serenità, un’accettazione che è tanto difficile raggiungere.