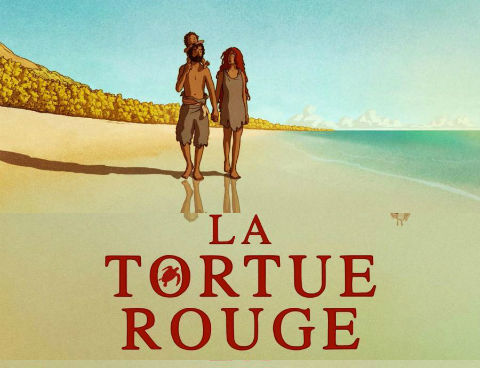La Scoperta dell’Alba: la recensione
Tratto, o sarebbe meglio dire ispirato, al romanzo omonimo di Walter Veltroni, il secondo lungometraggio di Susanna Nicchiarelli, La scoperta dell’alba, rappresenta un bell’esempio di regia intesa come interpretazione ed appropriazione – che spesso deve anche essere indebita – del lavoro, di un’idea generata e sviluppata da un altro. Un protagonista maschile con una casa, una famiglia forse non perfetta, un buon lavoro e una vita stabile quello del romanzo, una donna dalla vita in via di definizione, senza figli, in cerca di una nuova casa col compagno, Caterina, la protagonista del film, che sembra essere stata creata pensando alla futura interprete, la più congeniale: un’ironico-tragica Margherita Buy.
Nell’Agosto del 1981 – e anche qui la Nicchiarelli si allontana dal romanzo, ambientato nel ’68 – il professor Lucio Astengo, padre di Caterina e Barbara, scompare nel nulla dopo l’assassinio dell’amico e collega Mario Tessandori. Trent’anni dopo, siamo nel 2011, le due sorelle decidono di vendere la casa al mare di famiglia, lasciata in eredità dalla madre che è appena deceduta. Una casa che è stata testimone, insieme alla famiglia Astengo, di quegli anni difficili, ancora funestati dal terrorismo e già proiettatti verso i colori pop e la spensierata agiatezza degli anni ’80. Una casa che custodisce ricordi dolorosi: è qui che Caterina, Barbara e la madre ricevono la notizia dell’omicidio di Tessandori e il luogo in cui trascorrono l’ultimo giorno come una vera famiglia con Mario. Ed è proprio questa casa-custode che permette a Caterina di riallacciare i nodi di un’esistenza spezzata, di una famiglia distrutta. A pochi giorni dall’anniversario della scomparsa del padre, Caterina ritrova attaccato alla presa del telefono della casa al mare il vecchio apparecchio. Quasi per gioco compone il numero della vecchia casa di Roma e come per magia instaura un contatto con la se stessa di trent’anni prima, con la bambina seria e già troppo consapevole che, a pochi giorni, perderà suo padre.
Forse, fra i desideri più grandi ed irrealizzabili dell’uomo, molto più forte di quello di volare o di conoscere galassie sconosciute, c’è il desiderio di poter tornare indietro nel tempo per rimediare a un errore, per cambiare il presente, per indagare su un passato misterioso. E al cinema, meglio che in letteratura, i sogni più assurdi diventano possibili. Anche se solo per la durata di un incantesimo nel buio. Succede anche in questo caso. La storia di Caterina, la sorella maggiore responsabile e presaga, e di Barbara, l’indifesa ma non meno consapevole, ha permesso alla regista di ricreare un passato comune riconoscibile dallo spettatore, a partire da ricordi personali, da esperienze private, luoghi e oggetti che appartengono all’esistenza passata della regista, e che inevitabilmente appartengono un po’ a tutti coloro i quali quegli anni li hanno vissuti. Le ha permesso di ricreare, insomma, un immaginario collettivo, un passato condiviso. Questo bisogno di ricostruzione del passato, che abbiamo già incontrato in Cosmonauta e che si attua attraverso l’appropriazione, il calarsi completamente in un tempo lontano portandone alla luce i ricordi personali e privati che si collegano alla Storia con la s maiuscola, spiega la necessità della regista di essere anche interprete del film. Una necessità di sentire più proprio ciò che si sta facendo, e di non cadere nella trappola di voler delineare un quadro fedele e obiettivo della Storia che è solo presunzione. A partire da questo, la regia della Nicchiarelli si fa attenta alla resa dei particolari, alla ricostruzione affettiva degli ambienti, delle abitudini (l’aerobica fatta in casa) dell’epoca, alla restituzione di oggetti simbolo come il telefono a disco, la boccia col pesce rosso nella stanza di Caterina, lo strumento musicale giocattolo di Barbara.
Una fantascienza che si mette al servizio della ricostruzione storica e sociale di un’epoca a partire dall’esperienza privata. E sicuramente è questo bisogno di partecipazione, di attinenza personale alla storia che spiega la fluidità di certi movimenti di macchina, la preferenza della steadycam, l’uso del ralenti e della musica liquida e dilatata dei Gatto Ciliegia come strumenti necessari alla veicolazione di una buona dose di pathos e del coinvolgimento dello spettatore, che più che seguire l’intrigo, il mistero da svelare, si compiace di rivedere e di rivedersi in un’altra epoca. Se, infatti, c’è qualcosa che convince meno del film, sta nella gestione della componente misteriosa, noir della storia, in un inizio troppo lento che attarda l’approdo all’evento scatenante, nelle sottotrame poco sviluppate e nei personaggi secondari, che assolvono perfettamente la funzione umoristica di alleggerire l’atmosfera seria del racconto, ma che a tratti risultano da questa limitati.
Scritto da Vera Santillo.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Edoardo P. | ||
| 4 |