Le Belve: la recensione
Le Belve di Oliver Stone. In tanti lo vorrebbero formato eighties: per intenderci, con lo smalto di Natural born killers. Ma con Le belve Oliver Stone è destinato ad alimentare questa nostalgia, per quanto l’ottimo cast ed un certo clima da divertissement patinato provino ad animare un pulp almeno gradevole, ma smaccatamente in carta da pacchi.
Ben (Aaron Johnson) e Chon (Taylor Kitsch) sono due amici di lunga data, che condividono tutto: dalla biondissima e un po’ hippie Ophelia, detta “O” (Blake Lively), alla lucrosa ed industrializzata attività di coltivazione e distribuzione della marjuana nella California del Sud. Il primo “seme” – non solo metaforico – dell’attività è stato portato dall’Afghanistan da Chon, ex marine. Ben, botanico, ci ha messo l’ingegneria gestionale. Gli affari funzionano, il ménage à trois pure. Ma un violento cartello di messicani vuole rilevare l’attività, o cooptarla. Non è una proposta, è un ordine: così vuole la femme fatale Elena (Salma Hayek), così impone il suo braccio armato Lado (Benicio del Toro). Un agente corrotto (John Travolta) si trova tra i due fuochi, ma è un dritto.
Le belve è un film che vorrebbe ruggire, ma a fatica biascica un melodioso miagolio. La guerra tra le due fazioni, raccontata per larghi tratti dalla voce fuori campo di Ophelia, verte sulla contrapposizione tra i trafficanti peace and love, che prendono il sole sulla terrazza, che vivono come in una comune un idillio molto abbronzato, con Ben che addirittura trascorre lunghi periodi in Africa per finanziare e supervisionare attività e beneficenza; e gli efferati messicani, rinchiusi nel buio delle cantine, dalla pistola facile, doppiogiochisti (Lado) o viziati (Elena). Entrambe, tuttavia, sono branchi di belve: né buoni né cattivi, ma sopravvissuti e sopravviventi, furbi e meno furbi, killer romantici o killer opportunisti.
Quando Chon assume la leadership dell’impresa e delle imprese, infatti, cominciano a fare capolino cecchini e squadre di assalitori militarizzati, profilando lo scontro come una vera e proprio guerriglia intermittente, interpolata da macchinazioni da Scarface dei poveri. Vorrebbe essere una guerr(igli)a santa, in nome dell’amore per Ophelia, rapita dai messicani: ma Ben e Chon, ibridando Danko e Cirano, sono troppo smanettoni di fucili e conti bancari per apparire serafici. D’altro canto, mentre Benicio Del Toro, butterato bravaccio, suda sette camicie per lordarsi nel massimo lerciume morale e fisico, è significativo il ruolo di Salma Hayek, maitresse sadica, ma che – racconta ad Ophelia – è stata costretta ad assumere la leadership per il fatto di averla ereditata dal marito, morto prematuramente; e soprattutto, sofferente – sia pure con una sensibilità un po’ caricaturale – per il rapporto lamentevole con una figlia che vive altrove e risponde con malcelato fastidio al cellulare.
Tutto il film, in fondo, è volutamente caricaturale, e le stesse maschere indossate dai rapitori sono una cripto-indicazione in tal senso. Si tratta, tuttavia, di una caricatura che ha smarrito il senso feroce e surreale dello Stone degli anni ottanta, per diventare gioco scoperto, incapace di sviluppare l’ambigua savagerie in una convinta vena creativa, ripiegando piuttosto sul gusto hollywoodiano di accozzare interpreti familiari ed affidabili (John Travolta è uno spassoso venditore di fumo) e su una serie di saporosi clichè della violenza: dagli stupri agli omicidi, dagli ultimatum alle torture, dalle esecuzioni agli amplessi carnali. Eppure, già nel prologo, quando alle immagini in formato videocamera di torture dei sequestrati segue la voce flautata di una Blake Lively ancora troppo gossippara in bianco e nero sullo sfondo marino, tutta l’artificiosità del prodotto è evidente: presto prende piede un colore saturo, da “metti uno sgozzato a Laguna Beach”. Insomma, più fiction che pulp, termini tutt’altro che antitetici, certo: ma l’effetto dello scontro tra bande – i soliti trafficanti, tra l’altro – sa più di schermaglie tra adolescenti in qualche romanzo per ragazzi che di regolamento di conti: romanticismo stucchevole, finzione, riciclaggio invece di dark humour, marciume, inventiva.
Con Le Belve, Oliver Stone smonta e rimonta le convenzioni più o meno spettacolose del thriller d’azione con le figurine dei già noti di Hollywood, ma il montaggio è niente affatto innovativo. Può anche piacere, ma di un piacere sdrucciolevole: si scivola, anche troppo (più di due ore) su una fotografia di broccato e su di una scia di sangue che sembra marmellata.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Alice C. | Giusy P. | ||
| 7 | 1 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast:


































































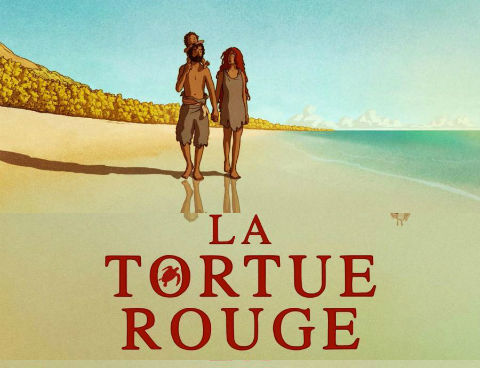










































Infatti se non fosse così lungo me lo rivedrei in originale anch’io 🙂 Il doppiaggio di Salma Hayek è la parte peggiore, gestito a random… “E’ una putana?” quando poi usano “de puta madre” o qualcosa del genere più avanti… il tutto intervallato da frasi in italiano con voce impostata e senza accento. Peccato, perché Elena era un bel personaggio (a parte qualche riserva spoilerante 🙂 ). Il finale più che un colpo di coda mancato è un colpo di zappa sui piedi 🙂
Per fortuna l’ho visto in inglese 🙂 Non voglio spoilerare sul finale, ma l’ho trovato veramente ingenuo. E’ stato un colpo di coda mancato!
A me il film non è dispiaciuto, anche se mi è rimasto il senso di occasione sprecata (ma meno che per Red Lights). Il cast era azzeccatissimo, anche se la bigamia, lo shopping insensato, le droghe e la deriva finta-hippy non sono certo una novità per Blake Lively (leggi: Serena Van Der Woodsen teletrasportata dall’Upper East Side alla Southern California). Non si spiega poi il viso slavato alternato al trucco perfetto in certe scene della seconda parte, ma son dettagli. Più fastidioso invece il doppiaggio, che non riesce nell’arduo compito di rendere la connotazione ispanica in modo realistico: parole in finto spagnolo alternate a frasi in italiano perfetto e senza accento… mmmh. Per tacere del finale… molto meglio la prima versione 😉 Ma forse ho visto troppo Breaking Bad e ho aspettative un po’ elevate sul cartello messicano 🙂