Cosmopolis: la recensione
Con Cosmopolis, presentato all’ultimo Festival di Cannes e tratto dal profetico omonimo romanzo di Don DeLillo (2003), David Cronenberg sperimenta una lettura della crisi economica contemporanea che si regge su un linguaggio visivo efficacissimo e sulla dicotomia cara al regista tra uomo e macchina, qui declinata nella contrapposizione tra automatismi impalpabili e corporeità corruttibile, tra la pretesa dell’immobilità (immortalità) e l’attrazione per il caos.
Eric Packer (il sufficientemente ambiguo Robert Pattinson) è giovane, geniale e multimilionario, ossessionato dal controllo e destinato a soccombere. Tutto porta verso quella direzione: le conseguenze sempre più oscure di un sistema economico che a tutti i livelli è scollato dalla realtà delle cose; la presa di coscienza di tali conseguenze e la realizzazione della fine di un modo di pensare i soldi e i flussi economici, di arricchirsi e dunque di esistere.
Eric Packer ha il pretesto di un banale e futile scopo (“aggiustare il taglio”), un mezzo di trasporto che lo isola dal resto del mondo (la limousine) e nessuna necessità di venire a contatto con l’esterno, qui rappresentato da una Manhattan congestionata dal traffico e dalle contestazioni causate da una visita presidenziale. Eric, simbolo di tutto ciò che il presente detesta, e profeta di un capitalismo impalpabile fatto di flussi informativi e cifre anziché di tempo produttivo quantificato, sfida la città viva e inferocita, contro ogni logica e ogni raccomandazione, e si spinge con movimento spiraliforme ad incontrare la propria volontaria autodistruzione. Essa comincia quando il giovane milionario perde il controllo sul suo intuito, trovandosi improvvisamente impreparato alla lettura di ciò che ha determinato la propria ricchezza.
Contemporaneamente Eric sperimenta la fascinazione crescente per ciò che solitamente tiene lontano attraverso vetri oscurati, guardie del corpo, pannelli di sughero: l’esterno, la morte, la violenza fisica. Con un certo compiacimento osserva l’aggressione splatter al presidente del Fondo Monetario Internazionale, e il sorrisetto beffardo affiora anche quando viene sorpreso dai contestatori armati di topi morti. Il vuoto emozionale permea la limousine: i momenti di vulnerabilità sono segnati da motivazioni egoistiche o incomprensibili, relegati in due tra le migliori sequenze del film, la visita medica con spettatrice e il funerale del rapper tanto ammirato da Packer da essere colonna sonora del suo ascensore. Certo, parlando di fisicità, il sesso è previsto anche prima, quello esposto e visibile con le amanti e quello invisibile rimandato e parlato, caratteristica di una vita coniugale potenziale ma di fatto inesistente (la moglie Elise è l’algida Sarah Gadon). L’esperienza del matrimonio (di convenienza) sta in un altrove inaccessibile, assieme alla merce, ai soldi, agli sfruttati e agli sfruttatori nelle loro oggettive corporeità, alla vita stessa: Eric Packer sta al di sopra di tutto, almeno finora.
Quando Eric inizia a perdere il controllo, inizia anche a spogliarsi: la giacca, la cravatta, la macchina, se invece che spostarsi nel flusso del traffico come fa nella prima metà del film, scende da solo, dall’auto parcheggiata (e viene prontamente sanzionato con torta in faccia dall’eccessivamente caricaturale Mathieu Amalric). Va ad incontrare se stesso, preparandosi nell’antro immoto del barbiere, surrogato paterno che viene dal passato e che gli parla per l’appunto del genitore: il simbolismo qui è caricato al massimo, il taglio di capelli “asimmetrico” e malfatto è un ulteriore dettaglio che avvicina Eric alla sua nemesi Benno Levin, un Paul Giamatti brutto vecchio e sporco spinto da una simile ambizione all’omicidio, all’uccisione mitomaniaca del simbolo. Qua la metafora si fa ingombrante, esplicita e spiegata, tra barlumi di autoconservazione (lo sparo alla mano è per sentire la propria esistenza) e concessioni al cliché del folle illuminato: la chiave di tutto è quella “prostata asimmetrica” assurta a simbolo della disfatta di Eric per incapacità di concepire la disarmonia, dettaglio apparentemente trascurabile che determina il crollo del tutto.
Cosmopolis non è perfetto, scivola qua e là nella in una rappresentazione macchiettistica, e sconta un finale che può apparire inadeguato rispetto alla complessità e alla stratificazione del discorso portato fin lì dalla sceneggiatura. Ricorda talvolta i dialoghi di Lynch e le atmosfere di Jarmusch, e non certo per difetto; impeccabile invece la regia, perfette la scelta dei piani e la progressione dalla claustrofobica vicinanza della limousine e degli ambienti limitrofi all’apertura notturna, fino alle sequenze molto meno segmentate dello scontro finale. Un film ostico e squilibrato, che necessita seconde visioni: e che pure è un grande esempio di consapevolezza del linguaggio cinematografico e della possibilità che esso sia ancora mezzo per sperimentare all’interno dei confini della narrazione.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Alice C. | Barbara N. | Edoardo P. | Giacomo B. | Giusy P. | ||
| 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast:


































































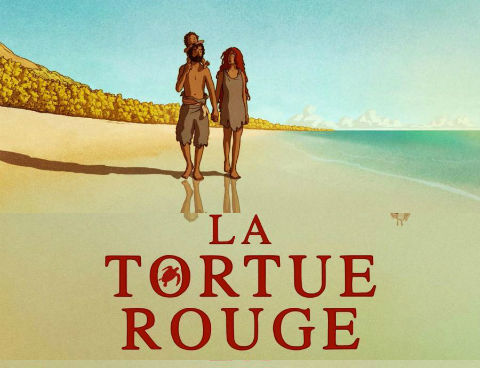










































Decisamente un film ostico, che per buona parte del primo tempo spinge lo spettatore a cercare una chiave di lettura alternativa e ad aspettare particolari illuminanti, quando invece era già tutto scritto nella limousine, nel pretesto futile, nel sesso da un lato abbondante e dall’altro nullo, e via dicendo. Una volta che mi sono arresa al meccanismo mi sono immersa più agevolmente nel secondo tempo (anche i multisala hanno ripristinato l’intervallo, naturalmente con tanto di arrivo del carrellino di bibite e popcorn per spillare ancora più soldi…); un po’ tirato il dialogo del finale, ora naturalmente voglio leggere il libro per vedere com’era gestita originariamente quella scena. La regia è impeccabile (bellissima anche la sorta di split screen nell’abitazione di Benno), ma mi ha colpito ancor di più l’enorme silenzio, che forse ancor più delle immagini isola l’interno della limousine dalla caotica city that never sleeps. Pink-Floydianamente: “[a lost soul] swimming in a fish bowl”.