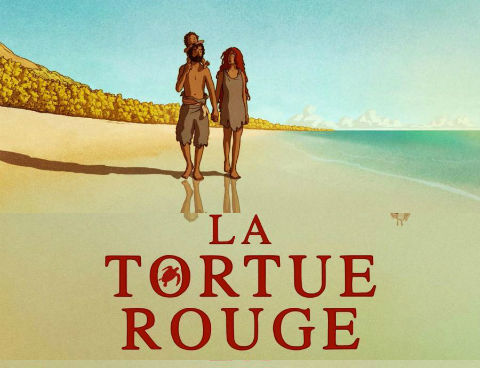Il primo uomo: la recensione
Il primo uomo di Gianni Amelio è opera più complessa di quanto appare. Segnata da una certa frammentarietà apparente, forse poco stringente in alcuni passaggi, sospesa e sfumata, quasi reticente. Ma c’è tutto l’uomo assurdo qui, la sua genesi e la sua rivolta incompresa.
Il film segue su un doppio binario temporale la vita ad Algeri di Jacques Cormery bambino e il ritorno nella terra natia del Jacques Cormery adulto, ricomposizione di un quadro esistenziale che passa attraverso gli affetti, i luoghi, le idee. Gli affetti sono incarnati da una madre dolente e discreta, una nonna matriarca che si riscatta dalla miseria col rigore e la dignità, uno zio semplice, un padre sconosciuto morto in guerra e il maestro che per primo vide in lui il germoglio dell’uomo che sarebbe diventato. I luoghi sono intrisi del sole del Mediterraneo, quel sole che determina l’essere e lo nutre della sacralità dell’immanenza. Dice Albert Camus nella Prefazione a Il rovescio e il diritto:
Per correggere un’indifferenza naturale venni messo a mezza strada tra la miseria e il sole. La miseria mi impedì di credere che tutto sia bene sotto il sole e nella storia; il sole mi insegno che la storia non è tutto.
Una condizione di distanza che condanna Camus e il suo alter ego Cormery all’impossibilità di una riappacificazione con quegli uomini che pure ama sopra qualunque cosa. E nel film si scorgono tutte le forme di questa lacerazione, in primis l’esperienza personale che si scontra con la collettiva e rende la realtà irriducibile ad un’interpretazione univoca: in questa situazione Jacques resta diviso tra la comprensione della rivolta algerina contro i coloni francesi, tra il senso di giustizia che lo avvicina ai vinti della Storia (si può stare dalla parte dei barbari gli dice il maestro ormai anziano) e la sua esperienza di pied-noir vissuto nella povertà, legato in modo indissolubile a questa terra e non certo per arrogante pretesa, così come la madre o il contadino con cui ha occasione di parlare mentre è in cerca delle tracce del padre.
La lacerazione si fa ancora più evidente in quei territori dello spirito, e della vita pubblica, dove il pensiero si fa spesso rigido e integralista. Il profilo politico di Jacques è sfuggente, egli diffida dei movimenti che mettono le idee davanti agli uomini, delle rivoluzioni che riducono l’uomo a forza storica, delle religioni e di tutti i credo, schiavitù volontarie che l’uomo preferisce allo smarrimento della libertà di scelta. Sono elementi questi che nel film emergono per brevi accenni e suggestioni, a volte quasi impercettibili, come il riferimento alla letteratura russa e all’amato Dostoevskij nel dialogo con il maestro. O che prendono forma compiuta come nel discorso all’aula, in cui Jacques perora la causa di una possibile riconciliazione e convivenza tra le genti o nel discorso finale che traduce in una frase, spesso male interpretata (tra la giustizia e mia madre scelgo mia madre), il senso di un intero percorso filosofico: la rivolta dell’uomo assurdo è con e per tutti gli uomini, in un orizzonte comune di finitezza; quando alla morale della comprensione si preferisce il giudizio, la rabbia e la disperazione ci si rende complici della creazione nell’aggravare il dolore e le ingiustizie a cui l’uomo è sottoposto.
Gianni Amelio si muove perfettamente in questo territorio, seguendo un ottimo Jacques Gamblin, malinconico e pensoso, negli ambienti di casa, nella casbah di Algeri, nelle campagne circostanti, con una regia asciutta e essenziale. Ma, come è ovvio, sono le sequenze dell’infanzia di Jacques, interpretate dall’esordiente Nino Jouglet, quelle in cui Amelio può esprimersi al meglio, nel delicato ritratto di ambienti e atmosfere famigliari, nei giochi e negli scontri dei piccoli protagonisti, a scuola e per le strade, negli scorci di questa città del Nord Africa così simile alla Calabria della propria infanzia.
Il primo uomo è opera più complessa di quanto appare, fatta di pensiero e passione, di una libertà pesante, carica di responsabilità, di azioni inutili ma necessarie. Ma è anche un’opera semplice che immortala la verità negli uomini e nei loro volti tirati, che la fotografia di Yves Cape rende insopportabilmente intensi, nei legami manifesti e sottesi, nel silenzio degli abbracci. Perché anche l’Uomo è un idea corta se ci si allontana dall’amore.
Scritto da Barbara Nazzari.
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Edoardo P. | ||
| 7 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast: