Shame: la recensione
Shame, il film di Steve McQueen passato a Venezia 2011, dove ha fruttato la Coppa Volpi al protagonista Michael Fassbender, mette a dura prova lo spettatore. Non tanto (non solo) per la quantità di sesso esplicito presente nel film, ma per il carico di disperazione sempre più oppressivo che accompagna la visione.
Perché Shame parla di questo: dell’incapacità di gestire una crisi profonda e senza nome, di una o più dipendenze palliative per tappare buchi e riempire vuoti in modo compulsivo, senza arrivare a nulla. Brandon Sullivan quotidianamente nasconde la sua dipendenza dal sesso nella più ampia accezione del termine. Non è sereno, anzi, ma è perfettamente capace di fingere indossando la maschera dell’affascinante uomo di successo, brillante e sagace, o taciturno e misterioso secondo l’occorrenza; ma non ha solo due facce, ne ha molte di più, come egregiamente sottolinea il volto iper-espressivo di Michael Fassbender.
La sorella Sissy (un’eccezionale Carey Mulligan), che impone la sua presenza dopo essere stata costantemente ignorata, è un’altra delle facce di Brandon, quella che lui ha deliberatamente soppresso da sé. La presenza di Sissy rievoca un passato doloroso dal quale la fuga non ha regalato tregua, né per Brandon, che, per perdersi, si è dedicato alla carriera in una città lontana e adatta come New York, né per Sissy, anche lei nomade aggrappata alla propria fragilità, dalla quale tuttavia assorbe l’energia per vivere e sentire; a differenza di Brandon, eternamente imprigionato tra la freddezza di un qualcosa che non può/non vuole estirpare dal proprio essere e la consapevolezza di sapersi facilmente mescolare agli altri, risultando molto più a suo agio dei colleghi (si veda il capo/compare di conquiste, così “trasparente” nel suo essere un marito traditore).
E’ Sissy che apre squarci nell’animo di Brandon cantando la sua struggente versione di New York New York, dilatata, estesa, infinita e che estirpa a forza una lacrima dagli occhi di ghiaccio del protagonista. Sissy è l’esplosione incontrollata di un’emotività che costringe all’azione, al pianto, al dolore fisico autoinflitto. La sofferenza è in lei tanto esplicita ed esibita quanto in lui è soffocata nell’ipocrisia dell’occultamento delle proprie (patologiche?) pulsioni.
McQueen ha il buon gusto di non dare una spiegazione a tanta tendenza autodistruttiva che in misura diversa affligge i due fratelli. Si limita ad osservarli nella loro complementarietà e nella loro diversità, nel loro sentirsi posizionati in modo sbagliato nel mondo (le molte riprese di spalle, le inquadrature che inglobano cartelli o squallide insegne “parlanti”), sullo sfondo di una New York indifferente ma dove tutto è concesso; e che ovviamente non dorme mai, come la fotografia del film sottolinea con giochi di luce artificiale e naturale, e il continuo alternarsi di colori caldi e freddi che riempiono l’inquadratura e si riflettono nelle differenze tra Brandon e Sissy.
Shame non è esente da qualche difetto: la prevedibilità di alcune tappe del percorso, come il fallimento di Brandon con la sola partner acquisita con un iter ordinario; o il sesso omosessuale messo al termine del percorso distruttivo, come scelta estrema di degradazione. Però alla fine restano negli occhi le molte sequenze perfette che raccontano Brandon e la sua personale disperazione: la disturbante scena iniziale nella metro, la corsa notturna, la cena e la chiacchierata con Marianne; e il finale, giustamente non risolutivo, forse un nuovo inizio, forse un inizio sempre uguale come l’ennesima corsa in metropolitana.
![]()
Continua a errare con noi su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Barbara N. | Giacomo B. | Davide V. | Sara M. | ||
| 9 | 9 | 6 | 5 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast:







































































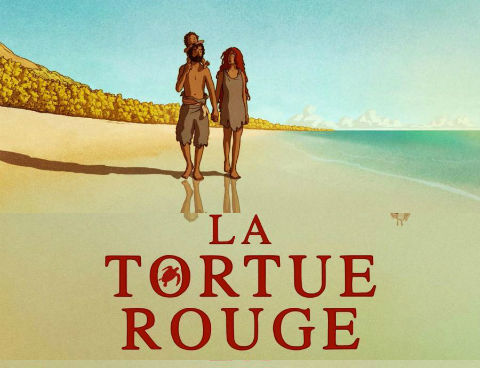










































ECCO! Vedi non l’avevo letta! Comunque si sono pienamente d’accordo! io l’avevo apprezzato e lo rivedrei per capirci di più guardandolo con calma e senza ansia da festival…FASSBENDER comunque si riconferma capolavoro dell’umana specie
Grazie, la recensione è molto interessante e ben scritta. Sono abbastanza d’accordo con lei, comunque nel constatare (con tutto il rispetto per la comunità gay) che è un gradino in più verso il regno delle tenebre per Brandon. E’ come per uno che sa di farsi un overdose ma ci va fino in fondo con il rischio di morire.
Comunque per me Shame è un film epocale e ringrazio Steve McQueen di avere avuto il coraggio di girarlo e dei suoi meravigliosi attori d’interpretarlo, perché di coraggio ce ne vuole molto, credetemi, a mettersi a nudo con l’anima (è più facile stare nudi in scena!) come hanno fatto quei due!
In effetti, confrontandomi con altri spettatori, molti hanno letto la scena nel senso che dici tu, come una sorta di ennesimo piatto da provare. Eppure ho provato fastidio a vederla posizionata, se non come ultimo gradino della degradazione (però il rapporto a tre è più un climax funzionale al parallelismo con la crescente disperazione di Sissy), comunque in fondo alla discesa, dopo che Brandon si è fatto pestare (e per me è evidente che va a cercare la rissa volontariamente), senza che prima si sia mai fatto cenno ad una sua eventuale bisessualità; forse può essere sottintesa dalla dimestichezza di Brandon con quegli spazi, ma mi rimane la sensazione di una scelta poco felice. Per completezza quindi ho inserito nella recensione la mia perplessità per quella sequenza, che pure, come spero si capisca, mi sembra una piccolezza in confronto al discorso generale del film.
Davvero grazie per il bel commento!
Bella recensione, ma mi permetto solo un appunto.
Non sono d’accordo con questa frase:
“il sesso omosessuale messo al termine del percorso distruttivo, come scelta estrema di degradazione.”
Innanzitutto perché dopo il rapporto omosessuale, Brandon ne consuma un altro eterosessuale (con due prostitute). Quindi il “termine” (se c’è) del percorso autodistruttivo (se tale è) è da collocarsi DOPO il rapporto a tre. Il rapporto omosessuale sarebbe, eventualmente, il penultimo stadio.
E poi, mi pare chiaro dalle scene in questione che Brandon sappia esattamente come comportarsi, cosa fare, quali porte aprire e quali corridoi percorrere per entrare nel club gay. Il rapporto omosex è, per Brandon, solo e semplicemente un altro rapporto – una “pietanza” diversa, ma equivalente alle altre, con la quale sfamare i propri appetiti.
Se io sono abituato ai ristoranti di lusso ma poi, alle tre del mattino, ho un attacco di fame e vado al fast food non mi sto degradando: mi sto semplicemente sfamando in un modo diverso dal solito.
A parte questo, grazie ancora per la recensione!
Giacomo, il tuo è tipo il commento più bello che si possa fare a una recensione! Grazie a tutti e due, sono contenta che siate d’accordo e soprattutto che vi sia piaciuto il film. Le pecche sono poco e niente in confronto a quello che rimane dopo la visione, ci ho messo un po’ a capirlo.
Quando una recensione è scritta così bene fa correre le persone al cinema, grazie anche da parte mia. Durante la visione la tua analisi scorreva sullo schermo insieme alle immagini. Ho apprezzato anch’io il buon gusto di non raccontare mai troppo (in contrasto con alcune scelte narrative sicuramente evitabili, ma non così disprezzabili) e la regia ferma e ricca di piani sequenza di McQueen. Il volto espressivo di Fassbender è immenso. New York, New York mai così intensa.
sono completamente d’accordo con te. ho apprezzato molto l’assenza di “psicoanalisi” nella scrittura, meno l’eccesso di contrasti (scene estreme, colonna sonora). inevitabile non subire il fascino umido di new york (siamo pur sempre sulla east cost), la corsa notturna su tutte, è cinema. e, scriviamolo pure, fassbender vale tutta la visione. ottima recensione, grazie!