Super 8: la recensione
È la fine degli anni 70, e la vita, in un sonnacchioso paesello del midwest ammeregano, scorre cinematograficamente parlando tranquilla: qualche tragedia famigliare, qualche nuova amicizia, il solito film in super 8 che la banda di regazzini protagonista della pellicola sta cercando di girare. Tutto questo fino a che un incidente ferroviario, con annesso arrivo dell’esercito sulla scena, non cambia le carte in tavola.
(attenzione, lievi spoiler)
L’ultima opera di J.J. Abrams si può pacificamente considerare come il tentativo, da parte dell’abilissimo produttore/sceneggiatore/regista, di prendere in consegna dalle mani di Spielberg quel ruolo di rivitalizzatore dell’industria che decenni fa fu dello stesso Spielberg (e l’avvallo è in un qualche modo ufficiale, visto che la Amblin ha coprodotto l’opera); un insider che sappia sì come funziona il sistema, e non ne sia disgustato, ma che anzi nutra una passione per il cinema in grado di raggiungere e sfondare la bruta considerazione commerciale.
Tutto, dalla trama alla fotografia, dai movimenti di macchina ai rapporti fra i personaggi è un capzioso omaggio alle pellicole con ragazzini di inizi anni 80 (l’unico vezzo contemporaneo che si concede il regista sono degli onnipresenti lens flare che, poco a poco, si mangiano letteralmente la scena). Quella dell’Abrams si configura fin dai primi secondi della pellicola non tanto come una semplice avventura nostalgica, quanto come una totale operazione mimetica, un riprendere non solo gli stilemi, ma pure il modus operandi dello Spielberg (e del Dante, e del Donner, e di altri ancora) dei primi anni 80.
Ma ci sono un po’ di problemi. Prima di tutto, se in Spielberg c’era sì un intelligente rimasticamento di materiali precedenti, c’era anche un’ironia di fondo, delicata e fondamentale, che permetteva a qualsiasi tipo di spettatore di abbandonarsi senza remore al procedere filmico; in Abrams, al contrario, c’è una riproposizione perfettamente assemblata, monolitica, che non prevede e non permette dubbi o ironie di sorta (tranne forse durante i titoli di coda), tanto che alla fine si ha la sensazione che più che di nostalgia ci si trovi di fronte a un magnifico (e magnificamente inquietante) museo delle cere, ben aggiornato dal punto di vista degli effetti speciali (che raggiungono comunque vette mozzafiato, come nella sequenza del treno).
Dal punto di vista delle relazioni fra i personaggi, il pezzo forte sono i rapporti con i genitori. Anche qui, però, c’è qualcosa che stride: le madri sono già tutte convenientemente morte o fuggite prima dell’inizio della storia, e l’unico personaggio femminile degno di nota è una sorta di Huckleberry Finn post litteram, un ragazzaccio che disubbidisce al padre, entra nelle altrui finestre di notte, e diventa indipendente prima degli altri, e che però, per esigenze d’intreccio (deve infatti ricoprire i ruoli di interesse romantico per gli altri protagonisti e poi quello di ostaggio da salvare), si presenta nelle vesti di donna (non siamo quindi di fronte a una inversione di stereotipi, quanto a un semplice camuffamento a uso narrativo).
Infine, per quanto riguarda la storia, se per qualche momento il mostrone può anche far pensare a un interessante correlativo oggettivo del non detto che c’è nel rapporto fra padri e figli, è un peccato che poi questo, assieme a tutto il resto, venga spiegato e spiattellato senza lasciar spazio ad alcuna immaginazione. E in fondo il problema di Super 8 è proprio questo, il fatto di essere un film nel quale tutto deve essere detto, chiarito, mostrato e sottolineato. Nessun elemento deve essere lasciato fuori, nessun sentimento deve rimanere sfumato, niente deve essere confuso o ambiguo: quando si giunge alla fine, tutto è chiaro e urlato, tutto è espresso in caratteri cubitali.
Il che fa sembrare J.J. Abrams, più che un nuovo Spielberg, un Dawson Leery giusto più scafato e accorto.
![]()
Continua a errare con noi su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Davide V. | Chiara C. | Leonardo L. | Sara M. | ||
| 7 | 7 | 8 | 4 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast:
















































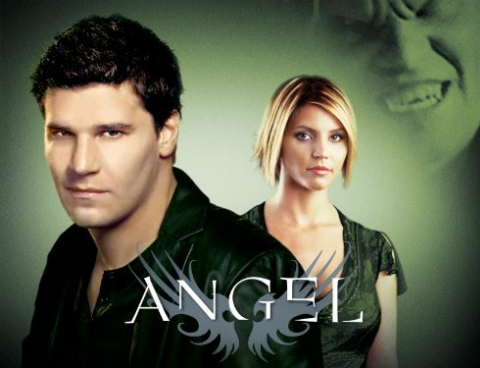










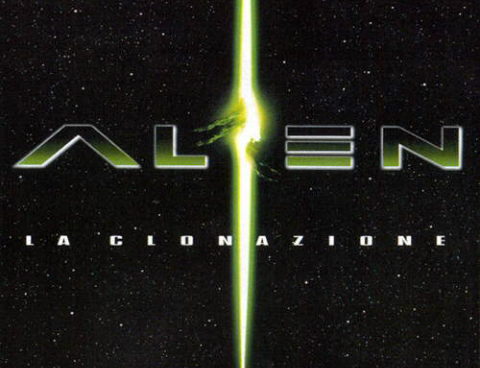
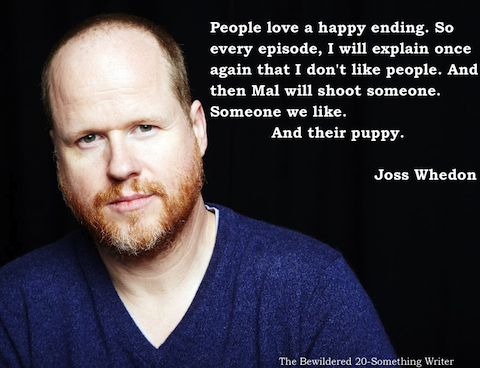




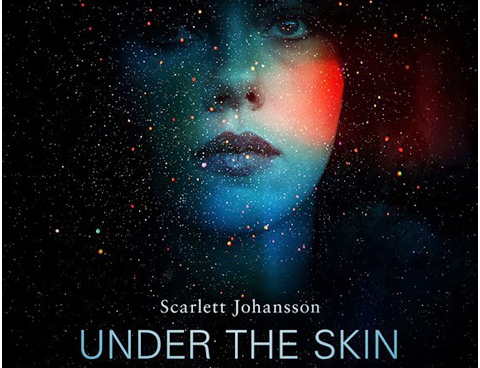

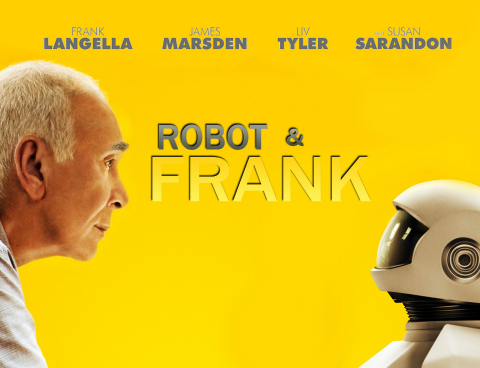





















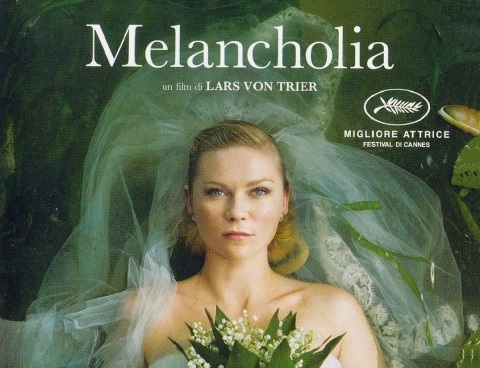













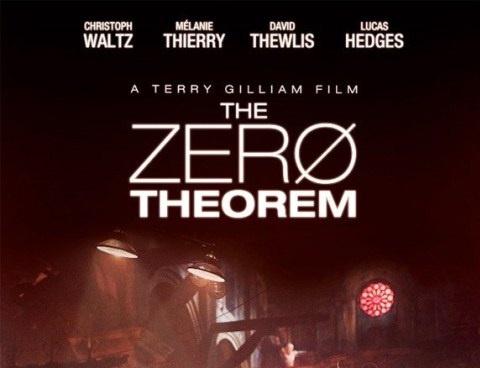






a me pare che il film funzioni all’inizio e alla fine, mentre in mezzo ci sia un megafono che urla continuamente in faccia allo spettatore quello che ci si aspetta da lui. Qualcosa tipo “ehi, adesso c’è da piangere! Piangi! Adesso c’è da trattenere il fiato! Adesso ridi! RIDI FORTE! Adesso temi per la sorte di quel personaggio! Adesso odia il militare! HAI VISTO CHE STRONZO?”, senza particolare grazia, e senza neppure una qualche sottigliezza che, al limite, farebbe sopportare anche tutto l’urlato.
Sono parzialmente d’accordo riguardo al fatto che Abrams riproponga, aggiungendo poco o nulla, tutti gli stereotipi del cinema fantastico adolescenziale fine anni Settanta/inizio Ottanta, però trovo che, nel suo dichiarato omaggio a quel genere, sia sincero e non tratti la materia come uno scultore con una statua di cera, bensì piuttosto come un nostalgico nerd desideroso di rivivere, e far rivivere, l’atmosfera di quel periodo. Mi è sembrato un film magari non troppo originale, ma non arido né noioso, anzi, mi ha coinvolto più della media dei film di fantascienza attuali.