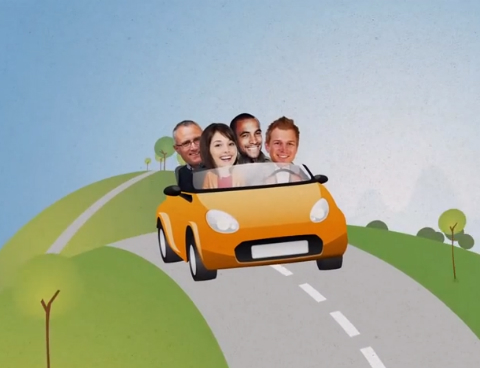EditorialediGiampiero Raganelli,6 ottobre 2015
Verso Sud, in Amazzonia a cena da amici

“Mi sto chiedendo chi siano i veri cannibali”: con questo interrogativo mormorato dal professor Monroe si conclude Cannibal Holocaust, apice del controverso filone cannibalico in voga in Italia negli anni Settanta-Ottanta. Torniamo a porci la stessa domanda con The Green Inferno, ora in sala, l’ultimo horror di Eli Roth che del cannibal movie di Deodato, Lenzi e compagnia vuole essere un esplicito omaggio. Quella frase stava a indicare il senso del politicamente corretto del film, pur con varie contraddizioni. Le popolazioni indigene praticano il cannibalismo, ma devono difendersi dai reporter che li hanno massacrati. Il valore del film di Roth è invece proprio quello di farsi beffe sull’imperativo assoluto, come è ormai diventato, del politicamente corretto. Già il titolo suona paradossale: il colore verde viene solitamente associato alla tranquillità della natura idilliaca, a tutela della quale si pongono associazioni che si chiamano Greenpeace. La natura impervia può, al contrario, trasformarsi in un incubo per villeggianti in cerca di tranquilli weekend, e per giovani che inscenano manifestazioni contro le multinazionali cattive, portati da un idealismo ingenuo a tutela del buon selvaggio. In un sol colpo Eli Roth si fa beffe dei ragazzi americani, benestanti, figli di papà, delle associazioni per i diritti civili e di quelle ambientaliste. Non dovremmo stupirci se qualcuna di queste organizzazioni protestasse, se non l’ha già fatto, contro il film. Vero che Roth, alla fine, conviene con l’ideologia di fondo di Deodato – ma come non sono buoni i bianchi se non da mangiare cotti a puntino in un forno tandori – ma in modo molto meno esplicito, concentrandosi sul come le vicende si ritorcano contro i giovani protagonisti che vengono imprigionati e divorati da quegli stessi indigeni che volevano salvare in una missione che peraltro si rivelerà tutt’altro che esente da manovre e strumentalizzazioni.
Roth dice di essersi ispirato alla controversa vicenda di Kony 2012, la campagna umanitaria scatenata su internet contro un criminale di guerra ugandese. Pur comprendendo – anche se questo Roth non lo mostra mai esplicitamente – che la violenza degli indios è una difesa rispetto a chiunque sia identificato come l’uomo bianco che li sta cancellando con le sue ruspe, come si può non sperare, noi con loro, che i bulldozer arrivino a salvarli, che una bella colata di cemento faccia piazza pulita di quel mondo ostile? Come possiamo non pentirci dell’ultima petizione che abbiamo firmato contro la deforestazione nei paesi tropicali? Nessuno arriva a un grado di fanatismo, e di follia herzoghiana, come quello di Timothy Treadwell di Grizzly Man, che in fondo in fondo poteva essere felice di fornirsi come nutrimento per i suoi amati orsi, con i quali conviveva. Possiamo obiettare a Roth che Kony 2012 potrebbe essere stata un’eccezione rispetto a tante iniziative giuste. Ma bisogna riconoscere come il regista riesca a mettere a nudo tante contraddizioni su cui si basa la nostra società moderna e pacifica.