Bone Tomahawk: la recensione
Un esordio sorprendente, che ammicca a Tarantino e lavora di pazienza
È un western, è violento fino allo splatter e c’è Kurt Russell: ma non è un film di Quentin Tarantino. Anzi, Bone Tomahawk non è nemmeno diretto da un veterano, segnando piuttosto l’esordio di S. Craig Zahler, sorprendente per il bilanciamento di tutti i suoi elementi: la durata, che potrebbe apparire eccessiva (132 minuti), ma viene gestita con saporite digressioni e sa caricarsi d’un magnetismo d’altri tempi; i toni, neri come tabacco masticato, ma pronti a illuminarsi, nell’assolata frontiera polverosa, di slanci di brillante umorismo; la fotografia, tra l’ocra e il grigio, tra l’arena e la sabbia, come una cartolina d’epoca pronta a macchiarsi di sangue.
Sequenza pre-titoli di testa: dopo aver tagliato la gola a un tizio – la prima promessa gore – due fuorilegge incappano nel cimitero di una tribù indigena: i membri non ne gradiscono l’intrusione. Uno viene subito eliminato, l’altro (David Arquette) fugge. 11 giorni dopo sarà sbattuto in gattabuia dallo sceriffo Hunt (Kurt Russell) nell’assopita cittadina di Bright Hope. Ma i conti non sono chiusi: i sanguinari attentatori si riprendono la preda, rapendo anche la guardia carceraria e Samantha (Lili Simmons), che stava curando il prigioniero ferito. Partono in quattro per recuperarli, stile Sentieri Selvaggi: lo sceriffo, il vice (Richard Jenkins), il marito della donna (Patrick Wilson), con una gamba spezzata, e un baffuto pistolero machista (Matthew Fox). Saranno sentieri insanguinati.
Si sparano pallottole e si rompono ossa, ma Bone Tomahawk è costruito per lo più su ritmi dilatati e su tortuosi dialoghi. Quando subentra la tortura e si dilacerano pelli nell’ultimo terzo, la sensazione è che la disinvolta virata in ferocia si manifesti in un contesto più raffinato rispetto all’irreverenza di genere, per almeno tre ragioni: è stata intanto creata un’alchimia tra i personaggi, che non sono, quindi, pura carne da macello; il confronto tra i quattro protagonisti ha fatto emergere diverse concezioni di virilità, elevandosi sul piano del significato rispetto al mero divertissement; anche nella scena più truculenta – un uomo tagliato in due a testa in giù ed eviscerato – non c’è il compiacimento del b-movie, quanto uno stile realistico per angolature e ritmi, a trasmettere efficacemente il senso dell’orrore del bianco di fronte al mostruoso selvaggio.
Sviscerato il film, non appare più sorprendente il fatto che il regista debuttante sia anche romanziere e musicista: c’è la pazienza della scrittura, la sensibilità dell’ouverture, la coscienza risoluta dell’attesa, l’ardore dell’accelerazione. Nel crescendo della disperazione, la macchina da presa si fa sempre più vicina allo sguardo inorridito dei personaggi. Non ci sono, quindi, solo chiacchiere fumose o pistole fumanti, né solo le frattaglie: tra il western e l’horror, s’insinua, tagliente come un tomahawk, la sottigliezza dei nervi logorati, come in un film drammatico. Che diventi o meno un cult, è un film coltivato.

| Antonio M. | Sara M. | ||
| 7 1/2 | 7 |
Regista: - Sceneggiatore:
Cast:








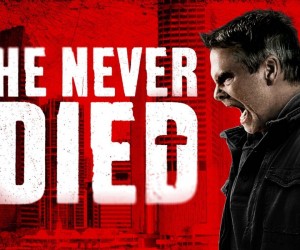












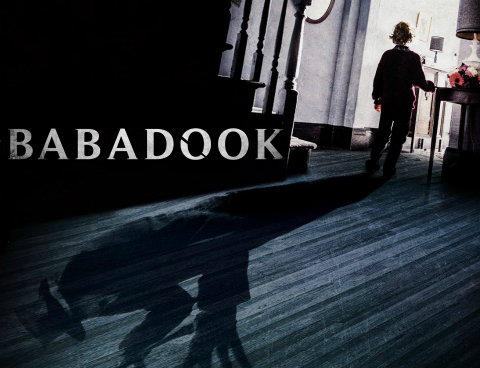
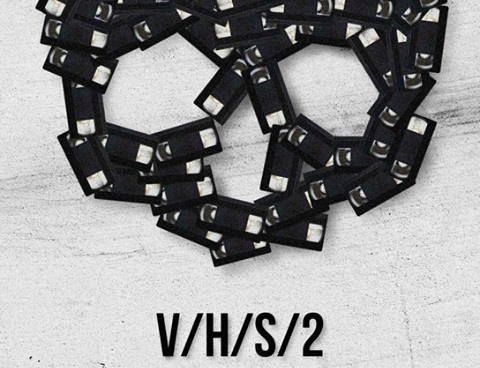































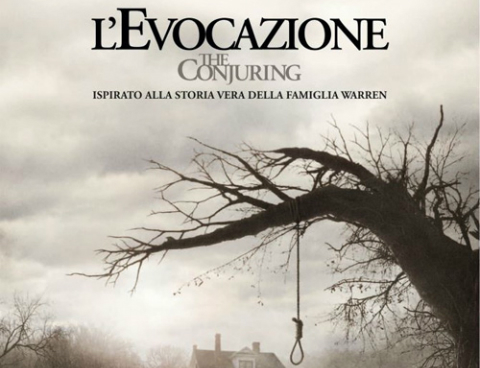
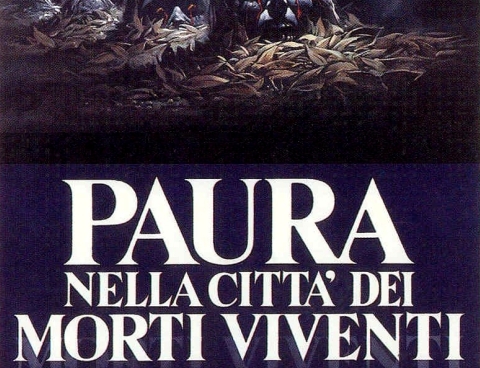








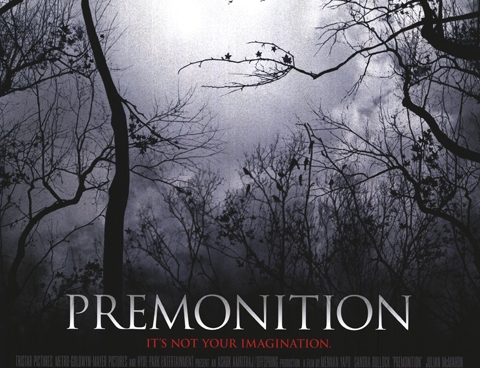


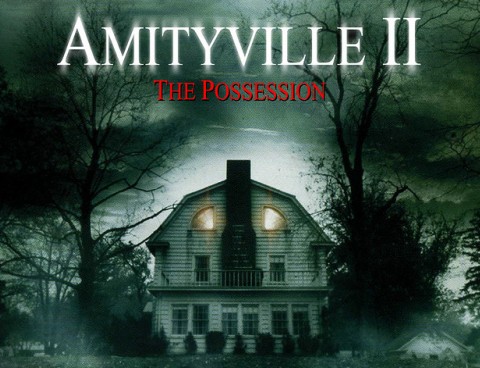




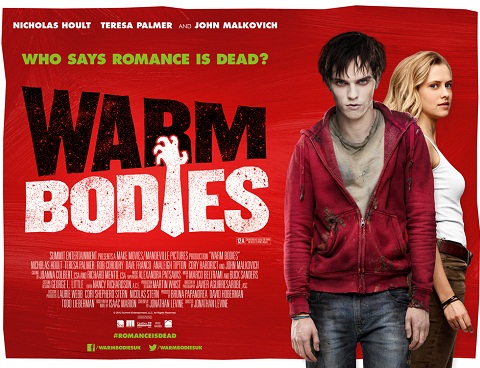













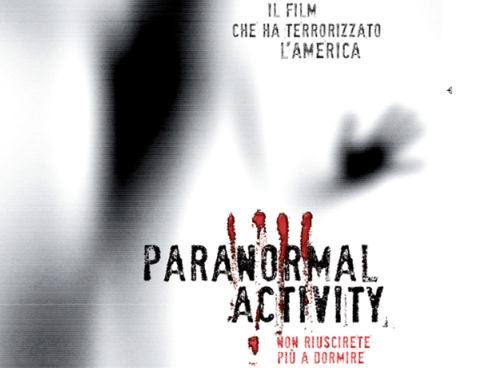


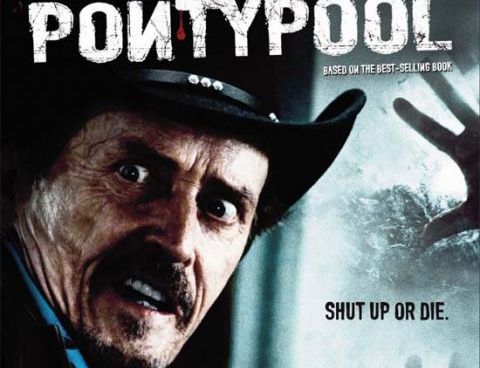

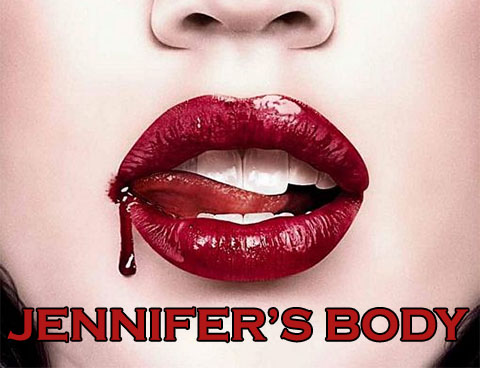

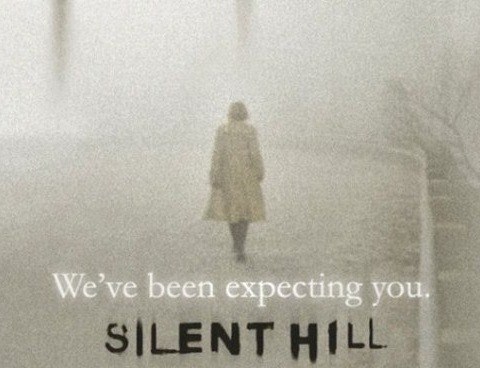






Un film che con qualche accortezza in più sarebbe potuto diventare una piccola perla del genere e non un semplice film che molto probabilmente ci scorderemo in tempi molto brevi se non per qualche piccola trovata interessante.
Qui il link della mia recensione completa: http://mgrexperience.blogspot.it/2016/05/bone-tomahawk-di-s-craig-zahler.html