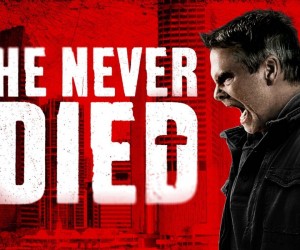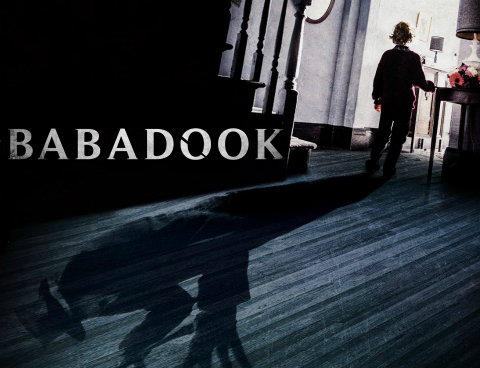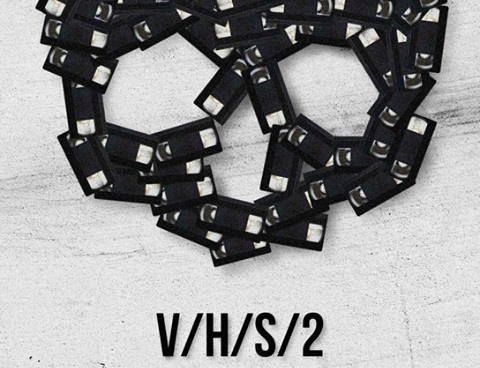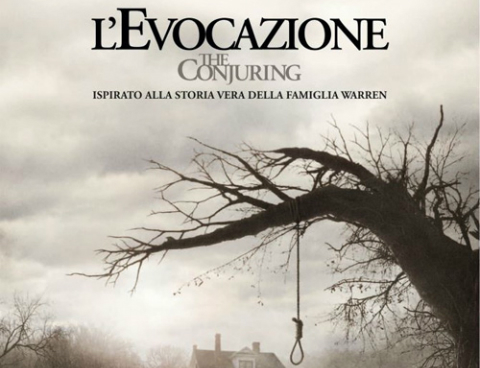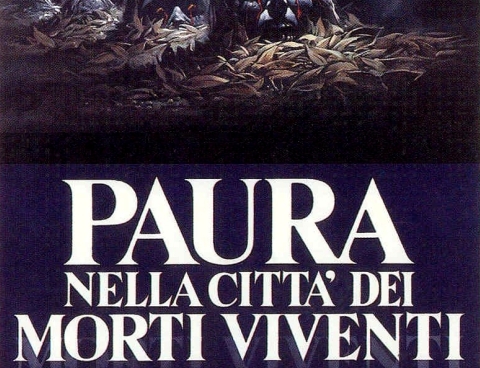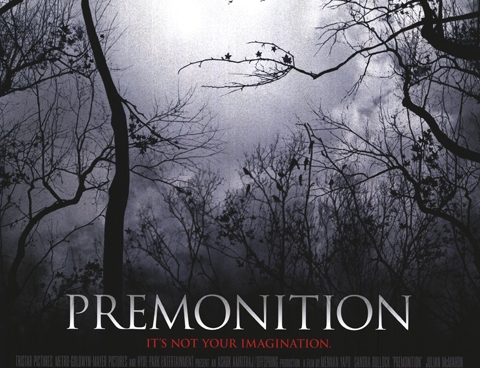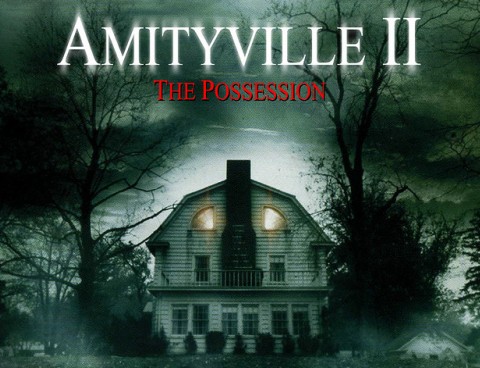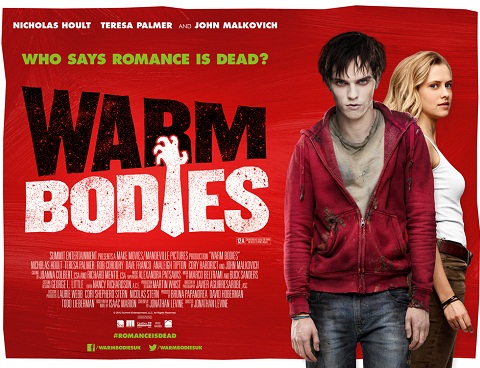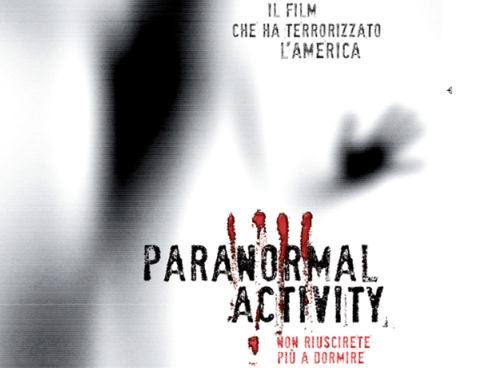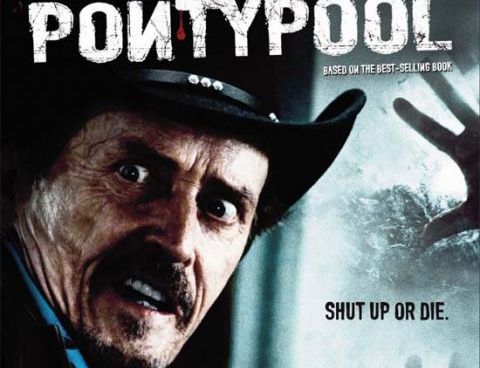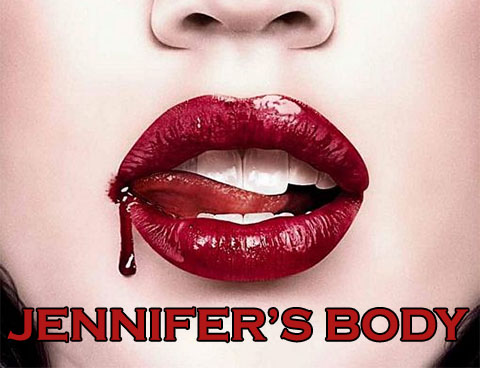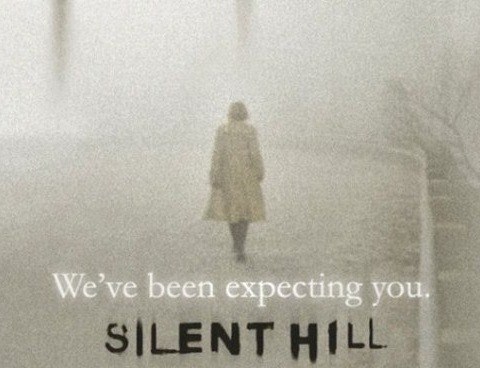Horror Ketchup – The Green Inferno: la recensione
Un cannibal movie che fagocita tanto cinema italiano. Cattiva digestione?
Era stato presentato in anteprima a Toronto, poi al Sitges, The Green Inferno di Eli Roth. Ma è in occasione dell’anteprima italiana che il film ha respirato, in qualche modo, “aria di casa”: se il regista è americano e la storia si ambienta nel Perù, è dall’Italia che vengono i numi protettori, anzi, i demoni etruschi di questo insanguinato cannibal movie, da Ruggero Deodato a Umberto Lenzi, fino a Sergio Martino. E non è solo oziosa questione di derivazioni, quanto di derive: nipotastro dichiarato dell’exploitation italiano, nonché più in generale epigono dell’ultraviolent tarantiniano rivisitato con la dozzinale mannaia del gore, Eli Roth con The Green Inferno sembra aver sfruttato – to exploit – così tanto l’eredità nostrana da averla completamente dissipata. Anzi: scarnificata, disossata. L’ostello in Amazzonia sarà pur accogliente per tanti amanti del genere, ma per una volta non sarà questione di campanilismo, semmai di responsabilità critica, dire: quanto ci manca il cinema di genere italiano.
A proposito di tribù: si siedono a terra e improvvisano canti, hanno i propri riti e sono coesi. Ma non sono indigeni d’Amazzonia: si tratta dei gruppi para-studenteschi di attivisti che manifestano davanti casa di Justine (Lorenza Izzo), figlia di un importante membro dell’Onu, avvolta nella bambagia, ma non tanto da isolarsi dai cori di protesta. Spinta dagli ormoni oltre che dall’ideologia – quanto è fascinoso il barbuto Cheguevaretto di turno (Ariel Levy), che incalza col megafono – la ragazza si associa a una missione apparentemente eroica al punto giusto, innocua al punto giusto: andare nella foresta amazzonica a bordo di uno scalcagnato aereo privato, incatenarsi agli alberi che stanno per essere abbattuti e fronteggiare i mercenari al soldo delle multinazionali con l’arma (si spera) letale dei cellulari. Intoccabili, dicono, con lo streaming in tempo reale: il problema è quando gli attivisti capitano tra le mani di una tribù di cannibali, che non hanno idea di cosa sia Youtube, ma possiedono un iperattivo tubo digerente.
ARMA LETALE – Una fotocamera vi seppellirà: è questa, in filigrana, l’implicazione social chic del film di Eli Roth, ossia il finto potere di social media e sharing, così finto che il nodo alla gola della rete si stringe proprio sul gargarozzo dei giovani che volevano utilizzare il network per le proprie battaglie fighette. Al punto da essere puniti sadicamente, seppelliti a loro volta – a pezzi: e qui, insieme al crollo delle loro velleità, sboccia il purulento sadismo exploitation, con i pacifisti vessati senza pietà con ben altre armi d’ordinanza dei mitra dei corpi di guerriglia sudamericani. Perché le armi, queste sì letali, sono i canini, e i corpi sono quelli dei giovani finiti in gabbie contornate da sentinelle indigene: corpi sinistramente simili a primo, secondo e contorno. Messo in chiaro che i signori della guerra non si fermano a colpi di tweet, specie se il capobanda degli attivisti è marcio, a Roth non resta che spiattellare, per rendere polposa l’argomentazione, una miriade di frattaglie. The Green Inferno diventa, dunque, una lunga mattanza, in cui s’indugia sui preoccupanti rituali canori e di body painting – inquietante la sciamanica figura femminile – non meno che su quelli, vien da dire, culinari, angoscianti perché senza angoscia, una spicciola antropologia documentaria.
ARMA E LETAME – Dovrebbe far contrasto l’angoscia delle vittime predestinate, nella classica situazione di pericolo in terra straniera (Hostel, ma è un cliché di genere iper-sfruttato: di recente, su tutti, Turistas), nonché di fuga impossibile dai torturatori. La costruzione della suspense è tuttavia sacrificata a ben altri altari cinematografici, quelli dell’horror postmoderno – diciamola tutta: di tanto horror da La casa 2 in avanti – in cui si è così consci del trucco da non poter far a meno di ironizzare, da non poter far a meno di ridere. E a proposito di trucchi: mentre il solito mostruoso Greg Nicotero compie un lavoro d’eccellenza realistica, Roth rende scoperto il fake drama con le iperboli del cattivo gusto: dalla tarantola che passeggia sul pene dell’attivista, al prigioniero che si masturba per scaricare la tensione, fino all’attacco di diarrea annunciato a trombe levate dalla flatulenza di un’avvenente fanciulla, che mai più sarà avvenente. Ecco perché si fa fatica a scomodare i vari, serissimi Deodato e Lenzi, cannibali ben più feroci di questi allestitori di spettacolini tipo metti una bionda a cena, in cui si succedono innocue efferatezze d’ogni tipo. Una cena senza delitto, una grossolana pietanza da consumare come un menù turistico, ma a cui manca la saporosa truculenza di fondo del cinema nostrano, tutta dispersa in superficie, come una spezia che condisca carne andata a male.
E se tanti, istradati dalla clamorosa panoramica d’apertura, hanno voluto dare la caccia alle citazioni dal primo (Cannibal Holocaust), dal quale ci si allontana nella rinuncia al found footage ma ancor di più in quella a un ruolo attivamente sadico degli esploratori, è sorprendentemente il secondo (Cannibal Ferox) a salire infine alla ribalta, nell’atteggiamento della protagonista di fronte alle autorità nel finale-non finale. Già, perché l’olocausto continua: pare che li seguito sia già in lavorazione, ci si deve mangiare a tutti i costi con le multinazionali del franchise. Poco male, ne verrà fuori un altro film… che fa poco male: un altro tiepido divertimento citazionista, un altro dignitoso green, white and red inferno che rigurgita citazioni italiche.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
Regista: - Sceneggiatore:
Cast: