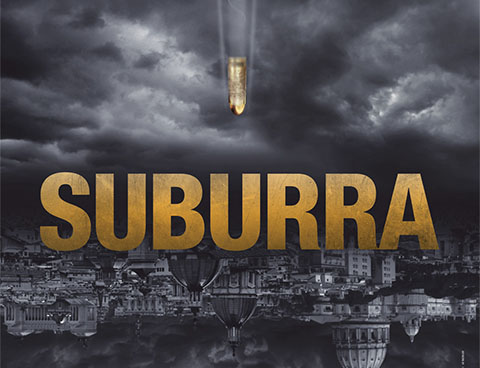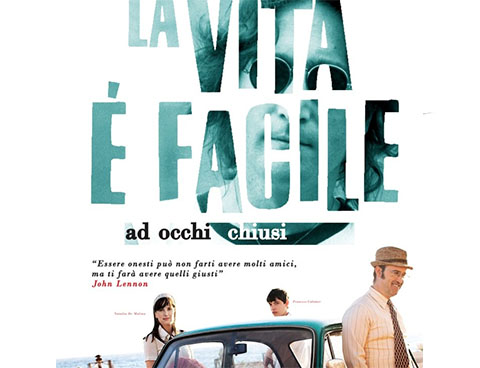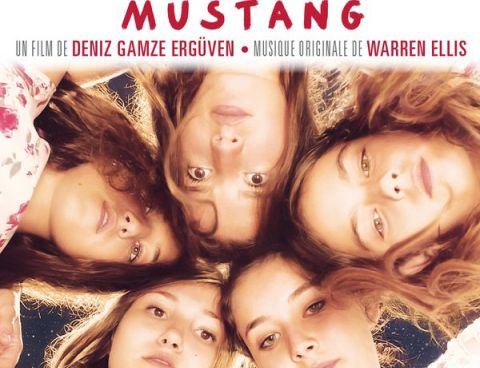AltrodiBlogger Erranti,22 settembre 2011
The Drums – Portamento
The Drums, Portamento. Dopo il post-punk e il post-dubstep, il post-questo e post-quell’altro, potremmo deciderci a definire una volta per tutte il post-hype. Quel genere – omnicomprensivo – in cui stipare le “next big things” che, dopo essere state incensate su magazine e blog di mezzo mondo, si apprestano all’altare sacrificale del secondo album e ne escono spesso e volentieri ridimensionate.
I Drums da New York City non sfuggono ahimè alla tradizione, presentando di fatto tutti i limiti che seguono un esordio a suo modo fresco e brillante, in cui un paio di singoli azzeccati avevano fatto gridare forse in troppi al miracolo. Miscela di canzonette surf adolescenziali belle da ballare per un’estate e malinconie smithsiane, l’ex quartetto di Brooklyn (ora diventato un trio) riconferma in buona sostanza la formula dell’esordio, finendo però per incartarsi laddove si necessitava maggior immediatezza.
Qualcuno dirà che si sono evoluti, che stanno semplicemente attraversando un periodo di crescita umana e professionale; oppure che l’autunno è giunto infine anche su di loro facendo crollare le illusioni estive. Sarà. Il fatto è che a un ascolto distaccato seppur superficialmente piacevole si ha la netta sensazione di brani che non andranno da nessuna parte se non nel dimenticatoio.
E questo non perché certe sonorità risultino sorpassate, ché da queste parti ci si immerge sempre volentieri nello Sturm und Drang, ma in virtù del fatto che la scrittura di Portamento non è a livelli propriamente memorabili.
A fronte del primo singolo estratto (Money) che cerca di riprendere il discorso da dove lo si era interrotto lo scorso anno, troviamo infatti le insipide I need a doctor e Please don’t leave. I don’t know how to love riveste i Joy Division di un sicuro pop da cameretta, non certo stanza di solitudine e fantasmi di curtisiana memoria.
Le nostalgiche Days e How it ended possono risultare gradevoli se lasciate dovutamente in sottofondo mentre In the Cold offre struggimenti un po’ a buon mercato.
Lavoro nel complesso segnato da un utilizzo maggiore dell’elettronica, in Searching for heaven si scomodano addirittura gli Ultravox di Vienna e i loro tappeti di synth da decadenza mitteleuropea: annotare che questo brano sia forse il più interessante del lotto rende – sigh… – l’idea.
I believe that when we die, we die, canta Jonathan Pierce. Sì, lo crediamo anche noi. L’importante è non morire di noia.
![]()
Scritto da Fabio Plodari.
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.